
Ancestors: The Humankind Odyssey lotta contro il divertimento ostinato
Ancestors: The Humankind Odyssey è un videogioco che non diverte. Anzi, richiede tanto sforzo e forse non ripaga come ci si aspetti che faccia un titolo capace di vincere premi ai The Game Awards. Eppure questo non è un problema: anzi è uno dei suoi pregi.
Nelle prossime righe proveremo a spiegare perché il divertimento non è – e non deve essere per forza – un elemento indispensabile in un videogioco. Prima di scavare a fondo però, è importante capire perché questa grande opera abbia un Metacritic così basso.
Se non diverte è brutto
Il videogioco, a differenza degli altri medium, troppo spesso è vittima di una ostinata ricerca del divertimento, soprattutto nel gameplay. Molti di voi staranno pensando che sia normale che il gameplay di qualsiasi gioco debba cercare di essere divertente e, magari, per molti altri il divertimento è addirittura indispensabile, il fine ultimo di qualsiasi videogioco.
Questa forte propensione del videogioco al dover divertire però, presta il fianco a diverse critiche che si possono riassumere con qualche semplice domanda retorica: ogni volta che si va al cinema ci si aspetta il divertimento? Quando leggiamo un romanzo drammatico ci aspettiamo divertimento?
Se volessimo raccontare una storia di pedofilia o una storia di riscatto sociale dovremmo per forza farlo con un gameplay divertente? Perché se guardiamo “Il miglio verde” (Darabont, 1999) non ci aspettiamo il divertimento ma se giochiamo a The Last Guardian (Team ICO, 2016) ci lamentiamo del gameplay che non diverte?
Queste semplici domande racchiudono il problema del videogioco intenso come medium espressivo: la condanna a dover divertire sempre, anche quando un gioco vuole essere drammatico, tragico o magari istruttivo, pedagogico o esperienziale.

Il videogiocatore è ormai educato a dividere il gameplay dalla narrativa, spesso addirittura a considerarli due segmenti separati e distinti. Pertanto, non è difficile passare tre ore filate a divertirci sparando, saltando, uccidendo e rotolando per poi commuoverci subito dopo nella cut-scene drammatica che segue il classico gameplay frenetico e divertente.
Possiamo supporre che questa capacità mentale del videogiocatore di ragionare a compartimenti stagni sia dovuta ad una tendenza produttiva che ci ha abituati ad associare il videogioco al divertimento. Non siamo abituati alla noia quando giochiamo, non siamo abituati al ritmo lento e non siamo abituati qualche sezione di gameplay fastidiosa che vuole trasmettere fastidio. Per questo motivo il già citato The Last Guardian, un gioco che rinuncia ad un gameplay divertente per farci vivere un rapporto drammatico tra un bambino e un animale in pericolo, molto spesso risulta noioso o un brutto gioco, sia agli occhi del pubblico che agli occhi della stampa specializzata.
Ugualmente, l’epilogo di Red Dead Redemption 2, sezione tra le più potenti, riuscite ed espressive del gioco, è considerato da molti giocatori come la più inutile e la più “pallosa“.
Il divertimento nei videogiochi viene auspicato e ricercato anche dalla critica, dai recensori e giornalisti che, forse, dovrebbero attendere e valutare le intenzioni degli autori prima di giudicare negativamente un gioco senza quelle caratteristiche. Oppure semplicemente prendere atto che il medium videoludico ha un potenziale molto più complesso, capace di discostarsi dal divertimento a tutti costi.
Troppo spesso nelle anteprime o nelle recensioni di questo o di quel videogioco sentiamo frasi quali “auspichiamo che il gioco sia divertente” o “il sistema di gioco non ci è parso divertente, con ritmo lento e a tratti noioso”, magari commentando un gioco ispirato a Lovecraft e che sta cercando di incutere terrore. Forse lo sviluppatore non vuole divertire attraverso il gameplay, magari gli sviluppatori vogliono fare altro, come ad esempio comunicare un disagio o far sentire il peso di una situazione complessa o drammatica; sono queste le riflessioni che possono migliorare il medium.

Crediamo che sia ora di maturare dal punto di vista critico e dare credito a quei giochi che cercano di comunicare attraverso un gameplay o determinate sezioni che non si ostinano ad essere per forza divertenti.
A tale scopo, utilizzeremo Ancestors: The Humankind Odyssey come esempio di opera videoludica che non ricerca ossessivamente il divertimento nel gameplay, ma decide di proiettare l’interazione verso mete diverse.
Di meccaniche e sistemi
Patrice Desilets, autore di Ancestors: The Humankind Odyssey e papà di Assassin’s Creed, ha espressamente statuito che l’idea iniziale sia nata dalla voglia di concentrarsi al massimo sulle meccaniche di gioco più primitive, come il semplice muoversi in un ambiente 3D, utilizzare le mani per manipolare oggetti, gestire l’interazione fino dal micro management del proprio avatar, interagire con l’ambiente e con diversi elementi direttamente derivati da sistemi anziché dagli script.
Per questo motivo si è scelto di ambientare il gioco dieci milioni di anni fa e di dare al giocatore l’obiettivo di guidare l’evoluzione della nostra specie. Questi setting e concept ci permettono di vivere una vita strutturalmente più semplice, al comando di un avatar che dovrà sviluppare i più primitivi processi sensoriali e motori attraverso delle meccaniche realmente uniche, che si combinano a dei sistemi che non sono al servizio del giocatore.
L’obiettivo degli sviluppatori quindi, non è quello di far divertire il giocatore dandogli un mondo al suo completo servizio e ricco di attività da pescare, ma piuttosto far comprendere e soprattutto esperire, pad alla mano, determinate situazioni e difficoltà che hanno permesso l’evoluzione della nostra specie.

Per mettere in piedi questa esperienza, gli autori hanno deciso di costruire un gigantesco open world esplorabile liberamente fin da subito, ricco di sistemi che il giocatore dovrà comprendere attraverso la ricerca empirica.
Il gioco è colmo di sistemi che vanno avanti indipendentemente dal coinvolgimento diretto del giocatore e questo rende il mondo di gioco vivo, ostile e imprevedibile: la vegetazione muta col tempo, il passaggio del nostro gruppo di primati può letteralmente consumare le risorse circostanti costringendoci così a fare i nomadi per poter continuare a sostentarci.
Anche gli animali si muovono, cacciano, prendono possesso di un territorio e interagiscono tra loro (non sarà raro vedere una tigre dai denti a sciabola azzannare un cinghiale). Proprio per via di questi loro comportamenti il giocatore non può mai rilassarsi troppo durante l’esplorazione: da un momento all’altro potrebbe ritrovarsi una gigantesca anaconda alle calcagna e quindi sarà importante sfruttare la meccaniche dell’udito e dell’olfatto per scandagliare l’ambiente circostante.
Persino gli agenti atmosferici influenzano direttamente la nostra esplorazione: durante una forte pioggia sarà più difficile vedere e sentire eventuali minacce, oppure il freddo ci indebolirà facendoci stancare molto prima.

L’ambiente è estremamente coerente e realistico, non essendo presente un game – e level – design a servizio del giocatore, pronto ad offrire attività ed elargire ricompense; pertanto, è molto facile mettersi nei guai. Allontanarsi troppo da un fiume potrebbe risultare in una scampagnata presso luoghi dov’è complicato trovare dell’acqua; scendere giù da un dirupo potrà condurre il fruitore in un luogo privo di risorse e, se troppo stanco, non potrà più risalire e tornare all’accampamento. La morte permanente completa il quadro concettuale del gioco, che non ci tiene mai per mano e ci punisce ogni qualvolta ci si approccia con troppa leggerezza al sistemico gameplay loop.
Questo open world si rivela essere un perfetto spazio nel quale far vivere direttamente al giocatore le difficoltà e i meccanismi del processo evolutivo umano.
L’evoluzione umana è un processo noioso, ma interessante
La progressione di Ancestors: The Humankind Odyssey è priva di script: il giocatore ha completo potere decisionale. All’inizio del gioco ci viene dato un obiettivo ben preciso attraverso questo messaggio:
Nelle prossime ore, rivivrai le sfide degli albori dell’umanità. Avventurati nell’odissea senza fine dell’evoluzione umana su questo pianeta. Usa il corpo, i sensi , la mente e la voce per guidare i tuoi viaggi. Espandi il tuo clan e fai evolvere la specie. Sopravvivi agli elementi della natura, insegna alla tua famiglia, costruisci una casa. In bocca al lupo. non ti aiuteremo molto.
Dal prologo di Ancestors: The Humankind Odissey.
Da lì in poi la palla sarà di chi è dall’altra parte dello schermo: è meglio cercare subito altri primati così da ingrandire la nostra comunità facendoli accoppiare o risulta preferibile andare verso l’ignoto in solitaria, esplorare, conoscere il mondo, capire come funziona la natura e imparare sempre nuove meccaniche? Meglio avere la pazienza di progredire piano, in sicurezza e in gruppo o tirare dritti spinti dalla curiosità di vedere nuovi luoghi o di affrontare nuove minacce?
Ovviamente, il mondo ostile, la progressione lasciata completamente nelle mani del giocatore e un open world ricco di sistemi che non sono mai direttamente al servizio del giocatore, necessariamente, comportano un ritmo di gioco per niente calibrato. Non vi è mai un momento “narrativo” costruito ad hoc intorno al fruitore. Il gameplay, essendo così tanto dipendente dai sistemi e dalle scelte del giocatore, potrà offrire dei lunghi momenti di quiete, di semplice passeggiate intervallate dalla raccolta di una pianta sconosciuta che dovrà essere analizzata e studiata empiricamente (mangiamo tutto, sperando che non ci avveleni).
Non sarà raro, quindi, trovarsi in situazioni definibili “noiose”, in cui non succede niente di elettrizzante. Intere sessioni di gioco potranno essere costituite da diversi minuti di esplorazione tranquilla, intervallata da un avvelenamento da curare passando diversi secondi a bere acqua da un ruscello, o magari da interminabili momenti al comando di un primate rimasto zoppo a seguito di un salto mal calibrato che lo ha fatto precipitare e rompere una gamba; magari culminando il tutto finendo dritti nelle fauci di un predatore.

Il gioco è strapieno di questi momenti che molti potrebbero definire “noiosi”: non c’è un checkpoint di cinque secondi prima che ci ri-catapulta nell’azione, non c’è un Atreus che parla dei miti norreni o fa un commento su una struttura in lontananza, non ci sono cinque segnalini a cento metri di distanza dalla quale è possibile iniziare un’attività secondaria. Ancestors: The Humankind Odyssey non vuole farci divertire a tutti costi, ingozzandoci di attività secondarie, combattimenti, dialoghi, messaggi a schermo, suggerimenti, fughe da templi in rovina o momenti emotivamente toccanti.
Panache Digital Games vuole, piuttosto, mostrarci come funziona l’evoluzione, dandoci la possibilità di partecipare attivamente all’evoluzione, magari accelerandola, rallentandola o modificandola. E lo fa costruendo un gameplay ricco di sistemi che obbliga a imparare le meccaniche con il metodo empirico, tracciando un un parallelismo con l’evoluzione umana.

Patrice Desilets e il suo team hanno deciso di far vivere in prima persona le difficoltà di questo lungo processo evolutivo, ricco di momenti esaltanti, pericolosi, avvincenti. Ma anche, molto spesso, di attimi noiosi come tolettare un membro della propria tribù o raccogliere cibo e piante per nutrirsi e curarsi di sé e degli altri.
Il gioco ha delle meccaniche complesse e diverse combinazioni di tasti, non basta premere R2+X per attivate la corsa acrobatica e liberarsi di tutti gli ostacoli in automatico; saltare tra gli alberi è impegnativo, c’è bisogno di timing e di calcolo delle distanze, serve attenzione continua. Per non parlare della manipolazioni degli oggetti. infatti il gioco presenta meccaniche molto concentrate fino al micro management del nostro avatar. con un tasto si potrà prendere un oggetto per terra, con un altro tasto si potrà spostare quell’oggetto da una mano all’altra mentre, con il tempo, sarà possibile imparare a prendere due oggetti contemporaneamente e farli interagire tra loro. Ad esempio, solamente provando a colpire il bastone con una roccia è possibile imparare ad appuntire un pezzo di legno e usarlo per pescare, colpire ed infilzare nidi di api o molluschi vari.
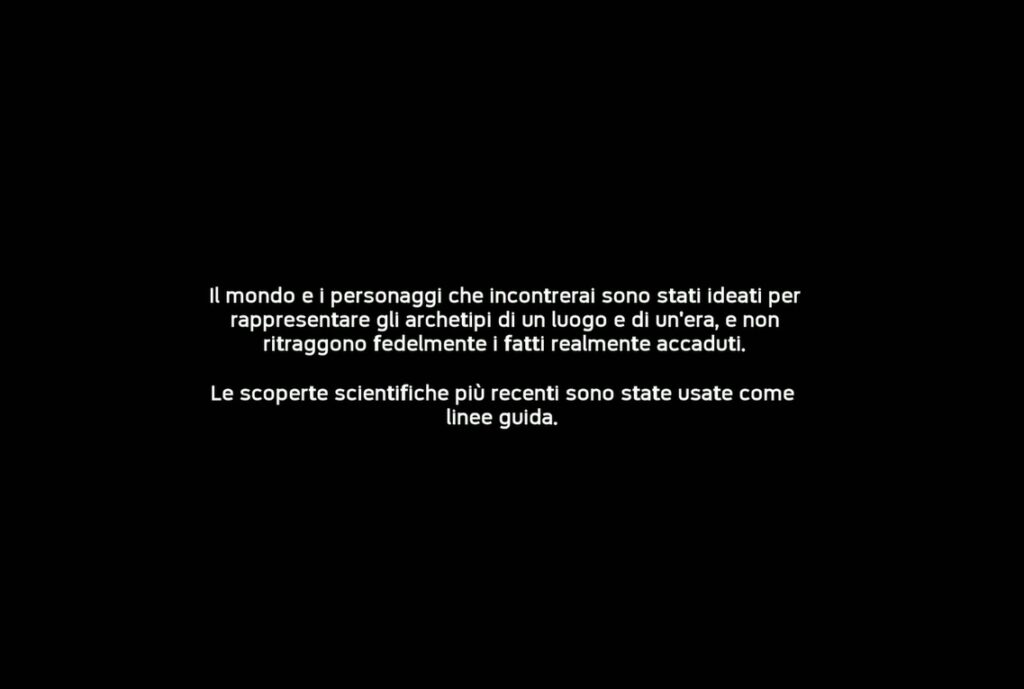
Mettersi nei panni di un antenato dell’essere umano è una vera fatica perché molti processi intellettivi che sono dati per scontati non erano ancora sviluppati dieci milioni di anni fa. Finanche il lasciare cadere un oggetto dalle mani mentre si corre potrebbe non essere così semplice: il multitasking va conquistato a suon di punti genetici e metodo empirico.
Giocando ad Ancestors: The Humankind Odyssey si imparano e si vivono tante esperienze legate all’evoluzione umana. non è certamente un gioco divertente e questo non è assolutamente un problema oggettivo. L’accessibilità non è il suo punto forte e il gioco si può definire ostico, complicato, pieno di pericoli, momenti morti e momenti esaltanti.
Proprio come possiamo supporre che sia stata l’evoluzione dell’essere umano.
VC
