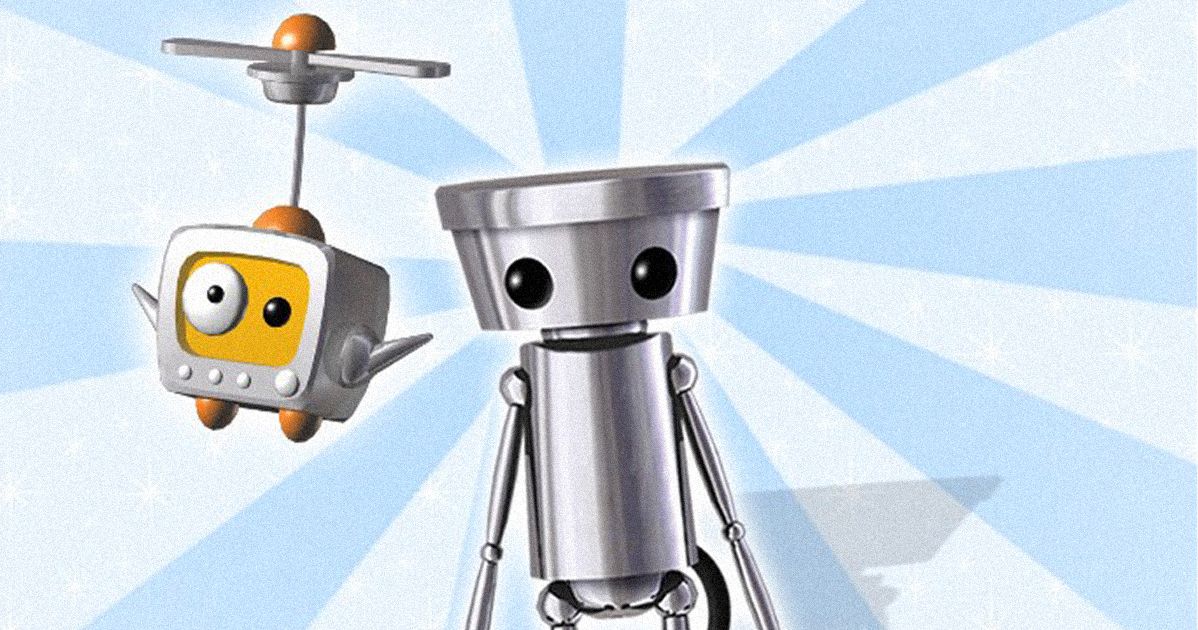Playdead: il silenzio è di chi lo riempie
Mass Effect e l’happy ending di Shepard: omaggio o rivalsa?
Far Cry 2 – 2008/2024: Affinità-Divergenze Postcoloniali tra il compagno Hocking e noi
Robert Nozick avrebbe giocato a Starfield
Chibi-Robo e la non violenza nei videogiochi
Chibi-Robo e la non violenza nei videogiochi

Fin dagli albori del medium, uno degli obiettivi più popolari e diffusi nei videogiochi è stata la prevaricazione o la distruzione fisica di un qualsivoglia avversario o antagonista, diffusa in così tanti generi e contesti diversi da rendere una constatazione così elementare quasi nebulosa col passare del tempo. Se al termine “nemico” sostituiamo quello di “avversario”, persino Pong è riconducibile a questa macro categoria. Certo, in ogni caso nessuno si è mai fatto del male (escluse eventuali baruffe extra-diegetiche, chiaramente), ma l’obiettivo della prevaricazione su quelle che sono le proiezioni digitali degli altri utenti è comunque una costante tuttora diffusa.1
È più che naturale che ogni tanto, quindi, qualche game designer abbia espresso il desiderio di ribaltare gli equilibri, di mettere invece al centro dei gesti che comunicassero bontà, generosità, amore e cooperazione. Chibi-Robo (GameCube, 2005-2006) non ha assolutamente il primato in questo intento, ma ne rappresenta probabilmente uno fra gli esempi più curiosi e intriganti. Concepito in origine come avventura punta e clicca, fu l’interesse del produttore di casa Nintendo Kensuke Tanabe a farlo uscire da una situazione di stallo a causa dell’abbandono da parte di Bandai. Dopo averlo portato all’attenzione di niente meno che Shigeru Miyamoto, il “padre dei videogiochi” rimase colpito dal robottino di casa Skip e decise quindi di adottarlo a tutti gli effetti, assicurandosi che venisse finanziato e pubblicato dalla casa di Kyoto. Il gioco, nel frattempo, cambiò anche genere, diventando un’avventura in terza persona.

Telly Vision non perde tempo e mette subito in chiaro quale sarà la nostra missione nel corso dell’avventura.
Questo titolo tutto da scoprire, e che ha fatto riscoprire la gioia del videogiocare a chi scrive in un momento di profondo sconforto nutrito proprio verso il medium, si pone l’obiettivo non solo di ridimensionare completamente il ruolo della violenza nella sua struttura, ma persino di rendere divertente e appagante il fatto di dare una mano nelle faccende domestiche. Nel mentre, Chibi-Robo riesce a rendere intrigante l’esplorazione della dimora della famiglia Sanderson grazie a degli escamotage che tratteremo a tempo debito. La famiglia di cui dovremo occuparci (i Sanderson, appunto) sta passando un momento piuttosto delicato, e le tematiche affrontate dall’opera di Skip creano un gusto agrodolce del tutto particolare una volta affiancate allo stile grafico vivace e dai colori accesi che lo contraddistinguono.
Questo articolo sarà strutturato in modo da contenere informazioni sensibili riguardo la trama solo in un’ultima sezione debitamente segnalata, in modo da non rovinare l’esperienza a chiunque voglia scoprire questo titolo purtroppo passato in sordina fin dal giorno della sua pubblicazione. Proseguite pure la lettura senza paura. O, perlomeno, per un po’!
La scuola Love-de-Lic
A proposito di videogiochi non violenti, e per rimanere in tema a più livelli con Chibi-Robo, è doveroso citare sicuramente la trilogia sviluppata dallo studio Love-de-Lic (ラブデリック), così battezzato in onore dell’album Technodelic, 1981, degli Yellow Magic Orchestra. Lo studio, fondato da Kenichi Nishi nel 1995, riuscì a lanciare sul mercato giapponese tre titoli prima della chiusura:
- Moon: Remix RPG Adventure (PlayStation, 1997)
- UFO: A Day in the Life (PlayStation, 1999)
- L.O.L.: Lack of Love (Dreamcast, 2000).
In particolare, Moon: Remix RPG Adventure rappresenta un esempio perfetto del tentativo di ribaltare i canoni, di mettere pesantemente in discussione le fondamenta del genere JRPG e il tutto, alquanto intrigante, per opera di diversi ex sviluppatori Square che, di conseguenza, avevano contribuito a reiterare le stesse nei progetti precedenti di punta della società giapponese ora nota come Square Enix. E non è tutto: Moon: Remix è stato infatti ripubblicato nel 2021, con tanto di traduzione in lingua inglese, ed è disponibile per Nintendo Switch, PS4, MAC e PC.

Le copertine dei tre giochi realizzati dallo studio Love-de-Lic.
Cosa succede davvero in un gioco di ruolo giapponese una volta che il giocatore non impersona più l’eroe di turno? Le gesta mostrate al giocatore sono davvero la realtà? Qual è il destino dei nemici sconfitti senza remore alcuna? Queste sono le domande che si pone Moon: Remix, un titolo che già nel 1997 costringeva i giocatori a interagire col suo mondo e i suoi personaggi in maniera molto diversa dal solito. Un tratto, questo, che troviamo anche proprio in Chibi-Robo.
Purtroppo, come anticipato, lo studio Love-de-Lic dopo la trilogia sopracitata sarà costretto a chiudere i battenti a causa dello scarso successo delle loro opere. Kenishi Nishi fonderà quindi un altro studio: Skip Ltd. È proprio in questa realtà che si troverà a co-dirigere Chibi-Robo insieme a Hiroshi Moriyama. Oltre a Skip, l’esodo dallo studio sfortunato farà nascere altre realtà come Punchline, in cui un certo Yoshiro Kimura2 sempre per rimanere in tema di giochi pacifici, creerà un videogioco totalmente incentrato sulla meccanica del bacio: Chulip3 (PlayStation 2, 2002). È degno di menzione, e piuttosto curioso, come egli sia anche la mente dietro una prima “bozza” di un titolo di cui si è parlato molto in Italia (seppur per le ragioni sbagliate): Rule of Rose (PlayStation 2, 2006). Se siete interessati a una panoramica più ampia dei videogiochi e dell’eredità dello studio Love-de-Lic, vi rimandiamo a un video splendido del canale italiano tutto da scoprire di Gekigemu.

Anche Chulip straripa di scuola Love-de-Lic e, come per Chibi-Robo, le musiche sono firmate da Hirofumi Taniguchi. Ne parleremo a tempo debito!
Per l’economia di questo articolo, invece, gli elementi che si ritrovano in Chibi-Robo riconducibili a questa filosofia di sviluppo sono sicuramente i seguenti:
– un ciclo giorno/notte in cui si inseriscono routine diverse sia dei personaggi umani che dei giocattoli presenti nella storia. Talvolta, questo si traduce nel bisogno di dover rispettare degli appuntamenti, dai criteri temporali più o meno stringenti a seconda del titolo, al fine di poter proseguire nell’avventura. Chibi-Robo, nel merito, è di maglia larga in quanto alterna azioni da dover/poter compiere nelle ore diurne o notturne.
– Un limite all’esplorazione effettuabile dal giocatore all’inizio dell’avventura puntualmente contestualizzato, in modo da permetterci di familiarizzare con l’ambiente in maniera graduale;
– Un’interazione con l’ambiente e i personaggi particolare, che costringe ad adottare e a sviluppare un nuovo modo di relazionarsi sia con lo spazio che con gli attori che vi si trovano. Il giocatore è spinto a entrare in sintonia, a conoscere e ad aiutare gli altri attori della storia sempre tramite approcci e processi positivi o, comunque, di natura non violenta.
– A ciascun personaggio è assegnato un gruppo di suoni, o per meglio dire “versetti”, riprodotti in maniera casuale durante i loro dialoghi, che quindi risultano intellegibili solo grazie ai sottotitoli. Ciò permette una caratterizzazione particolare e ulteriore, che può permettersi di andare al di là di ciò che potrebbe essere il semplice timbro o l’accento del doppiaggio tradizionale sfociando, tra l’altro, in derive anche comiche, e talvolta squisitamente grottesche, inaspettate.
Un piccolo robot, grandi responsabilità
È sera, e la famiglia Sanderson, cane Tao compreso3, è riunita intorno al tavolo del soggiorno per un’occasione molto speciale: l’ottavo compleanno della loro figlia Jenny. L’atmosfera è allegra e animata e la tavola è imbandita di bevande, cibi vari e una torta molto invitante. Eppure, fin da subito appare qualche ombra nel rapporto di questa famiglia: la moglie Helen, per esempio, rimprovera al marito i soldi spesi non appena scopre il regalo che il marito George ha preso per la figlia. Inoltre, Jenny indossa un costume da ranocchia e non parla mai, rispondendo sempre invece col gracidio di una rana (“Ribbit! Ribbit!”), un comportamento che viene rimproverato in maniera leggera sempre dalla madre. Il padre George, invece, sembra molto più spensierato e con una atteggiamento laissez-faire. Da cosa deriva tutto ciò? Difficile dirlo ancora, e tuttavia Chibi-Robo, fin da subito, mette in bella mostra alcune crepe del rapporto della famiglia Sanderson e che verranno sempre più a galla col proseguire dell’avventura.

La prima scena di Chibi-Robo è perfetta per calarci nel contesto della storia a più livelli.
Come potete immaginare, il regalo molto costoso che George ha deciso di fare a Jenny (ma probabilmente anche a se stesso) siamo proprio noi: un Chibi-Robo! Quanti videogiochi conoscete in cui impersoniamo un regalo di compleanno? E non un regalo qualunque, ma un robottino iper-tecnologico e pieno di risorse prodotto dalla Citrusoft Robotics in grado di aiutare nelle faccende di casa. E non è tutto! Compreso nel prezzo è presente anche il nostro manager svolazzante Telly Vision, che di fatto si occuperà di parlare per noi. Chibi-Robo, infatti, è in grado solo di dire di sì e di no (a discrezione del giocatore, ben inteso) facendo uscire un simpatico cartello dalla testolina metallica. Una testolina che, tra l’altro, a quanto pare è in grado di miniaturizzare gli oggetti raccolti a dismisura e che fungerà da inventario.
Dopo un’entrata in scena con tanto di luci e musica, Telly Vision verrà assalito da un tormento incredibile: siamo arrivati nel mezzo di una festa di compleanno a mani vuote! In quella che è a tutti gli effetti una piccola fase di tutorial ben congegnata, Chibi-Robo non dovrà fare altro che salire su un paio di oggetti posti sul tavolo e recuperare una rosa da dare in dono a Jenny. Sarà proprio questo piccolo gesto la fonte dei nostri primi punti felicità (Happy Points), una risorsa che ci permetterà di scalare una classifica condivisa con tutti gli altri robottini della Citrusoft. A scanso di equivoci, questa classifica non è condivisa con gli altri giocatori, ma si tratta di un modo simpatico ed efficace di spingerci a fare del nostro meglio in quanto, una volta raggiunti alcuni traguardi, verremo ricompensati con batterie più capienti che permetteranno esplorazioni più lunghe prima di doverci ricaricare tramite le prese di corrente (pena il collasso temporaneo, con tanto dispiacere e fiumi di lacrime di Telly Vision). Tutte le prese di corrente presenti nel gioco, tra l’altro, fungono anche da punti di salvataggio.

In quanto regalo di compleanno di Jenny, saremo incoraggiati a interagire con lei fin da subito. La figlia dei Sanderson è inoltre la protagonista di una quest secondaria che spingerà all’esplorazione della casa, oltre naturalmente ad avere un arco narrativo tutto suo.
I punti felicità vengono elargiti piuttosto spesso a fronte di qualsivoglia azione positiva, come togliere una macchia dal pavimento o buttare una cartaccia in un cestino; oltre a ciò, ogni tanto saremo ricompensati con la valuta presente in gioco, ovvero i Moolah (recuperabili anche tramite l’esplorazione), da usare nel negozio presente nella Chibi-House. Questa non è altro che la “confezione” tecnologica in cui torneremo per verificare la nostra posizione in classifica al termine di qualsiasi ciclo diurno o notturno (così come dopo un game over “energetico”). Oltre ad acquistare eventuali strumenti e oggetti, al giocatore è data la possibilità di variare la durata dei cicli diurni e notturni (5, 10 o 15 minuti) semplicemente comprando l’oggetto corrispondente a un prezzo più che politico.
Tuttavia, la fonte più intrigante di questi punti felicità è probabilmente l’interazione con la famiglia Sanderson (cane compreso) e con i giocattoli sparsi per la casa, che si animeranno ogniqualvolta non ci saranno esseri umani nei paraggi. Ciascuno di essi è caratterizzato deliziosamente sia a livello musicale che a livello di personalità, e non mancheranno di strappare qualche sorriso, sorpresa e, perché no, anche un piccolo momento di commozione. Come avrete forse già intuito, il punto sarà quello di capire ciò che li turba e portare anche a loro un po’ di gioia. E non è tutto: Chibi-Robo, infatti, riesce persino a infilare un paio di messaggi inaspettati in serbo per chi porterà a termine l’avventura.
Questioni di prospettiva
Tanto per essere chiari e fugare ogni dubbio, tutta l’avventura di Chibi-Robo si svolge all’interno della casa dei Sanderson, giardino incluso. Gli spazi esplorabili, di per sé, non sono molto numerosi: si tratta, dopotutto, di una casa a due piani abbastanza nella norma (per quanto deliziosamente realizzata). E tuttavia, ciò che rende accattivante persino girovagare sulla superficie di un tavolo o sui fornelli della cucina sono, banalmente, le dimensioni stesse del nostro avatar. Chibi-Robo è infatti alto appena dieci centimetri, e chi di dovere a Skip non si è lasciato sfuggire questa opportunità per dare una marcia in più all’esplorazione: ci troveremo infatti ad aprire file di cassetti pieni per formare dei gradini e raggiungere posti più elevati; ci arrampicheremo sul cavo di una lampada per raggiungere ripiani per poi planare dolcemente grazie al “chibi-cottero” verso luoghi altrimenti inaccessibili; anche gli oggetti sparsi sul pavimento e persino i pomelli dei cassetti potranno costituire un punto di appoggio. Insomma, fin da subito risulta lampante come le aree della casa siano state realizzate a misura di Chibi-Robo, rendendo l’esplorazione mai scontata e spesso piacevole.

La visuale in prima persona mostra anche gli oggetti chiave disposti nell’area, il che è un’ottima cosa considerata la prospettiva limitata del nostro avatar. Da notare anche il contatore della batteria in basso a destra.
Le nostre primissime deambulazioni inoltre, come anticipato, sono limitate da una batteria energetica contenuta (oltre che al soggiorno di casa), ma che potrà essere potenziata in men che non si dica dandosi giusto un poco da fare nelle pulizie. Questa scelta fa un grande favore sia al gioco che ai giocatori, in quanto valorizza al massimo i primissimi luoghi esplorabili e costringe, ma senza farlo pesare, a sviluppare un approccio consapevole ed efficiente con il nostro avatar. Ogni azione di Chibi-Robo, infatti, consuma energia gradualmente, costringendoci quindi a fare delle scelte di economia, a pianificare le nostre prime micro-esplorazioni e a familiarizzare quindi con l’ambiente come meglio crediamo ma, comunque, in libertà. Come possiamo raggiungere la sommità del divano? E quel ripiano laggiù?
E anche curioso e ingegnoso notare come il titolo usi talvolta la spazzatura da raccogliere come “faro”, spronandoci a perlustrare sempre nuovi angoli in virtù del nostro compito. Portare felicità? Beh, sì. Ma anche raccogliere rifiuti e pulire le macchie su pavimenti e muri. Per nostra fortuna, grazie a un marito poco attento e a un cane Tao iperattivo, la casa si sporcherà puntualmente ogni giorno, dandoci sempre un sacco di opportunità per scalare la classifica e di guadagnare qualche soldo mentre ci rechiamo verso la prossima destinazione. Man mano che si andrà avanti nella trama subentrerà anche qualche minigioco in modo da spezzare la routine; inoltre, da un certo punto in poi potremo piantare e far crescere delle rose da dare in dono a Helen o Jenny.

Sophie è il primo giocattolo animato che incontreremo. Nel pieno delle turbe amorose per un altro balocco della casa, offrirà da subito diversi spunti comici.
Come anticipato poco fa, il soggiorno costituisce una specie di tutorial allargato ma comunque fondamentale nell’avviare i primi eventi della trama, un luogo strutturato consapevolmente e che ci permetterà di familiarizzare (nonché apprezzare) i controlli una volta per tutte e anche di incontrare i primi esemplari di giocattoli animati. Ma anche questo limite spaziale sarà presto rimosso, permettendoci di esplorare gradualmente anche il resto della casa per conoscere tutti i giocattoli (e non solo) strambi e memorabili che la abitano. Oltre ad approfondire, naturalmente, l’equilibrio molto precario in cui si trova quella che piano piano diventerà anche la nostra famiglia.
E tuttavia, finora abbiamo trascurato probabilmente uno degli aspetti che rende Chibi-Robo un gioco molto particolare non solo da giocare, ma soprattutto da ascoltare. Oltre ad avere una colonna sonora strepitosa ed eclettica per opera di Hirofumi Taniguchi, il titolo si avvale di un approccio estremamente originale dal punto di vista degli effetti sonori.
La musica dei gesti
Quello di Hirofumi Taniguchi è un nome che si trova spesso dietro alle colonne sonore di altri titoli della scuola Love-de-Lic (come i già citati Moon, UFO e Chulip), ma egli in realtà si è fatto valere anche nell’ambito di videogiochi ben più noti di casa Konami quali Suikoden, Castlevania e Contra. Una carriera di tutto rispetto insomma, e il suo spirito musicale estremamente eterogeneo ben si sposa con la filosofia di Chibi-Robo. Come già accennato, ogni personaggio possiede il proprio tema musicale personale, puntualmente diverso rispetto agli altri sia nel genere adottato che nell’estro più o meno eccentrico eppure, puntualmente, in grado di costituire una costellazione musicale coesa ed efficace una volta affiancato al resto dei brani presenti nell’opera. Passare da una sigla da super sentai a brani di tutt’altro estro e respiro è la norma per Taniguchi.
Taniguchi dimostra di aver compreso appieno lo spirito di questo gioco, riuscendo ad andare ben oltre il semplice compito di realizzare una colonna sonora di tutto rispetto e accattivante. Non appena il simpatico robottino farà la sua primissima apparizione a schermo, infatti, farà sentire subito il suono dei suoi passi. No, non stiamo parlando di impatti semplici e discreti, ma bensì di note musicali vere e proprie, coerenti con la tonalità della traccia che accompagna l’azione. Inoltre, lo strumento musicale che darà voce alle esplorazioni di Chibi-Robo cambierà a seconda della superficie: avremo, per esempio, degli archi pizzicati per il pavimento e il suono morbido di una fisarmonica per le superfici accomunabili a questo aggettivo.

Lo spazzolino non è un oggetto qualunque: è infatti a forma di Space Hunter Drake Redcrest, il superoe preferito del padre di Jenny (che incontreremo ben presto in forma di giocattolo).
Ma poteva forse fermarsi qui l’ingegno di Taniguchi? Certo che no! La sua intenzione era infatti quella di restituire l’idea di un protagonista robotico, ma comunque in grado di compiere delle azioni inaspettate e originali: per questo motivo, qualsiasi gesto compiuto da noi sarà puntualmente accompagnato da piccoli motivetti composti da strumenti musicali e rumori meccanici solo sporadicamente, in cui l’altezza delle note sarà sempre coerente con la “direzione” dell’azione compiuta: quando si raccoglie un oggetto da terra per poi riporlo nella nostra testolina metallica, per esempio, il punto di riferimento per il “percorso” musicale sarà il movimento dell’oggetto stesso nello spazio.
A seconda dell’accessorio usato per rimuovere la macchia di turno, inoltre, Taniguchi provvede a impiegare uno strumento e un motivetto musicale diversi sempre puntuali che non potranno che farvi sorridere: strofinare il pavimento con uno spazzolino da denti, per esempio, scatenerà alcuni arpeggi deliziosi di chitarra classica. Tornando al suono dei passi, non è un caso che i temi di sottofondo del ciclo diurno e notturno non abbiano melodia: siamo infatti noi stessi, mentre giochiamo, ad andare a riempire quello spazio.
Tutta questa attenzione nel far risuonare le azioni del nostro avatar in maniera così vivace e allegra è profondamente coerente con quella che è la missione principale di Chibi-Robo: portare la felicità. E lo è talmente tanto da infrangere lo schermo e riuscire a portarla anche ai videogiocatori. Chi ha avuto dei cuccioli di animali da compagnia in casa sa benissimo come il semplice vederli scorrazzare in giro porti il buon umore e a posare uno sguardo nuovo anche su luoghi in cui siamo cresciuti. Chissà, forse Taniguchi pensava anche a questo mentre, giorno per giorno, andava a costruire questo amalgama di musica ed effetti sonori memorabile. Non bisogna scordare, inoltre, come Chibi-Robo non possa parlare direttamente con gli altri personaggi. Si può quindi concludere, probabilmente, come siano i suoi gesti, tradotti appunto in note musicali, a parlare per noi.

Quando Chibi-Robo solleva la sua spina viene riprodotto questo motivetto. Ora concentratevi sugli spinotti e provate a immaginare un pentagramma dietro alle immagini di gioco. Chiaro il ragionamento, no? Tutti i suoni dell’interfaccia di gioco, inoltre, sono vocalizzi di Taniguchi stesso.
Se leggendo fino a questo punto vi siete incuriositi anche un poco su questo titolo, noi non possiamo che esserne più che lieti.5 La storia di questo piccolo capolavoro semisconosciuto di Skip difficilmente potrà deludervi, grazie a un insieme di personaggi molto particolare e ben caratterizzato a più livelli (come già accennato). Chibi-Robo è un’opera con un buon equilibrio tra comicità e dramma, tra spensieratezza e parentesi più sentite, che crea un amalgama potente e accattivante che permane anche diverso tempo dopo la fruizione.
E tuttavia, concludere questo articolo senza alcuna riflessione riguardo le tematiche trattate nel gioiello di casa Skip sarebbe veramente un peccato. Se quindi siete sensibili ai cosiddetti spoiler e non volete giustamente saperne di più, correte a dare una mano in casa Sanderson e chiudete la pagina!
[Da qui in poi l’articolo contiene spoiler nel testo ed è stata quindi operata una “grassettatura” più selettiva.]
Il prezzo dell’efficienza
Finora siamo stati molto vaghi riguardo il rapporto burrascoso tra i genitori di Jenny6 e le altre dinamiche presentate in questo titolo, ma è giunto finalmente il momento giusto per essere un po’ più schietti. Ci sono due ragioni dietro questa tensione coniugale: George ha rinunciato al suo lavoro di punto in bianco e, a peggiorare la gravità delle cose, continua imperterrito a spendere un sacco di soldi in giocattoli (e non necessariamente per la figlia, per intendersi). Nel corso del gioco, dopo l’ennesimo acquisto compulsivo dello sposo, la moglie Helen arriverà a barricarsi in camera da letto in segno di disperazione e protesta. Il marito, che tra l’altro fino a quel momento era stato costretto a dormire sul divano ogni notte (Chibi-Robo, e noi, testimoni), riceverà un ultimatum: o inizierà a occuparsi un po’ delle faccende di casa o sarà il divorzio.
Come è facile immaginare, tutto ciò non farà che pesare ancora di più sullo stato d’animo della piccola Jenny, tanto che a un certo punto potremo vederla piangere sulle scale in piena notte ma, al tempo stesso, pronta a ricacciarle non appena vedrà Chibi-Robo. Tale disparità tra il tipo di situazioni presentate nell’opera, un elemento che potremo chiamare “escursione emotiva”, è sicuramente uno dei punti di forza della vicenda. La varietà di situazioni crea infatti un contrasto potente che, in quanto gestito correttamente, va a rafforzare in egual modo sia le situazioni più scanzonate che quelle più pregne e drammatiche della storia. Queste ultime, come accennato in principio, provocano un piacevole attrito ulteriore con lo stile grafico del gioco.

Non passerà molto tempo prima che Chibi riuscirà a riscattarsi anche con Helen, la madre di Jenny. Il rapporto si evolverà con l’avanzare della trama.
Kenishi Nishi si esprime proprio a questo proposito con queste parole:
Se ci si concentra solo sul divertimento e l’allegria, ne risente la profondità. Non c’è nessuna sorpresa in serbo per il giocatore se un titolo si mostra come un gioco allegro e l’esperienza dimostra di esserlo altrettanto. Non vi è più spazio per la sorpresa o tutto ciò che è inaspettato.
Liberamente tradotto dall’inglese dal numero 201 di Nintendo Power (2006), p. 33
Tornando al marito George, il suo ex-lavoro presso la Macroware Robotics Inc. è legato a doppio filo con una presenza che si limiterà in principio a farci solo qualche dispetto, per poi diventare sempre più invadente: gli Spydorz. Si tratta di piccoli esseri robotici a 3 gambe da cui Chibi-Robo dovrà talvolta difendersi grazie a un cannoncino energetico attivabile sul braccio (forse un piccolo omaggio a Samus Aran?). Distruggendoli si ricaveranno dei rottami, una risorsa da poter riciclare per costruire delle piccole infrastrutture al fine di raggiungere nuovi luoghi della casa prima inaccessibili.
L’aspetto più interessante, tuttavia, risiede nel fatto che questa minaccia inaspettata doveva essere in origine un amico e alleato degli innumerevoli Chibi-Robo presenti in tutto il mondo proprio per volere di George. Le cose, però, sono cambiate per volontà della società stessa, che li ha resi invece ostili e portandolo quindi alla decisione di dimettersi.
È interessante notare come la manifestazione di una certa forma di violenza all’interno di Chibi-Robo sia dovuta a una manipolazione in cattiva in fede di un progetto che era previsto come di tutt’altra natura. Non è chiaro perché la Macroware Robotics abbia fatto questa scelta: forse per spirito di competizione? In ogni caso, non è questo il punto. A noi piace pensare che l’intento di Kenichi Nishi e Hiroshi Moriyama fosse il seguente: mostrare come il capriccio di una ditta potesse cambiare completamente lo spirito di un’opera per qualsivoglia ragione contro la volontà del suo stesso creatore, tanto da costringere un protagonista di natura pacifica a difendersi con la forza e cambiando quindi gli equilibri di gioco stabiliti in origine.

Questi simpatici soldatini a forma di ovetto (i Free Rangers) saranno una delle nostre prime conoscenze e torneranno più volte nel corso dell’avventura.
Gli Spydorz sarebbero quindi dovuti essere pacifici proprio come noi, ma questo non avrebbe dato forma a quegli scontri per cui tanto, ancora oggi, si preme nelle grandi produzioni videoludiche. Si tratta forse quindi di una frecciatina/critica meta-referenziale? Il fatto che George abbia abbandonato la ditta, invece, potrebbe essere forse ricondotto al primo esodo da Square, da cui nacque lo studio Love-de-Lic di cui abbiamo già parlato.
La rosa dei personaggi presenti in questo gioco offrirebbe davvero moltissimi spunti riguardo altre tematiche, ma sarebbe impossibile affrontarle tutte senza mettere a dura prova la vostra pazienza. Vi è però un punto principe che bisogna assolutamente affrontare, ovvero quello ambientale.
Nella seminterrato della casa degli Anderson, infatti, è presente un Giga-Robo non funzionante a causa della sua batteria completamente vuota. Si tratta di un modello precedente a Chibi-Robo, molto più grande e che per un po’ fece da compagnia ai Sanderson portando, proprio come noi, un po’ di allegria in casa. Tuttavia, a causa dell’enorme mole di energia di cui necessitava, è stato spento per sempre e abbandonato in cantina. Prima che avvenisse tutto ciò, Giga-Robo ebbe però la fortuna di avere uno di quegli incontri del terzo tipo. Ebbene sì, l’opera di Skip non si fa mancare proprio nulla! Dopo aver salvato una piccola astronave mentre precipitava grazie a una presa tempestiva, gli alieni (che tra l’altro giocheranno un ruolo fondamentale anche per Chibi-Robo a tempo debito) offrirono di poter esaudire due desideri. E Giga-Robo fece le sue scelte: il primo fu quello di poter dare un’anima ai giocattoli, mentre il secondo di dare a tutti i Giga-Robo nel mondo un corpo che non necessitasse di energia per funzionare.
Purtroppo quest’ultimo desiderio non venne esaudito, in quanto gli alieni non avevano più “sfere di luce” (ball of light), necessarie proprio per esaudirli. Promisero quindi di tornare al loro pianeta, recuperare un’altra sfera e tornare non appena possibile. A causa di ulteriori difficoltà, che dovremo risolvere proprio noi nei panni di Chibi-Robo, questa soluzione al problema energetico è stata rimandata indefinitamente nella trama.

La situazione finanziaria dei Sanderson è probabilmente la fonte delle tensioni familiari, acuita da elementi collaterali quali l’atteggiamento generale del marito George e da come la loro figlia Jenny decide di estraniarsi da questo contesto, percepito ormai come ostile.
Si potrebbe pensare che il problema, tuttavia, fosse legato esclusivamente al grande fabbisogno energetico dai Giga-Robo. Purtroppo non è così: nell’ultima parte del gioco, un servizio del telegiornale Faux News dichiarerà come il gran numero di Chibi-Robo stia creando proprio lo stesso problema, ed è proprio in questo momento che si comprende il genio dietro quest’opera. Skip infatti prende proprio l’azione del ricaricarsi per poter continuare a funzionare, l’azione più importante e ormai scontata per noi, e la pone al centro del dibattito, di un problema molto serio e che minaccia conseguenze funeste per il futuro. Quante azioni compiamo durante la giornata che potremmo fare meglio o con più coscienza o lungimiranza? E quanti dispositivi sono diffusi oggi che però richiedono delle ricariche costanti per poter essere utilizzati? Ecco, forse è in questo istante che risiede il messaggio più potente di tutto il gioco, una chiosa incredibile e inaspettata su quello che già era un gioco molto speciale.
Non bisogna inoltre scordare come in casa Sanderson la continua produzione di rifiuti e sporcizia sia “positiva” a livello diegetico per noi, ma è facile intravedere anche in questa costante quotidiana una critica ulteriore allo stile di vita in cui ormai ci troviamo tutti. L’ultimo titolo di Love-de-Lic L.O.L.: Lack of Love, dopotutto, aveva questo titolo proprio per sottolineare una mancanza d’amore del genere umano verso la natura e l’ambiente
Se siete arrivati fin qui con la lettura ci avete appena donato ben 500 punti felicità! E anche se ora sapete tutto, credeteci quando diciamo che vale comunque la pena di fare un giro su questo titolo. Paradossalmente chi scrive, in questo momento, vorrebbe quasi dimenticarsi degli eventi della vicenda per poterlo affrontare come la prima volta.
LR
NOTE:
1 A onor del vero, e riflettendoci un attimo, questo approccio accomuna un po’ tutti i giochi di società tradizionali, molti giochi da tavolo, compresi i più moderni, e le attività sportive: in tutti questi casi, la competizione attiva verso un certo obiettivo è una costante. E tuttavia il videogioco, considerando anche il percorso che ha compiuto e che compie tuttora, è comunque degno di una analisi in questo senso in quanto si basa sulla creazione e riproposizione di un contesto virtuale creato da zero, in cui quindi le regole e le consuetudini potrebbero potenzialmente essere più facilmente ignorate a favore di approcci al di fuori dalla norma. Tuttavia si tratta di un discorso molto complesso e su cui l’autore di questo articolo non è assolutamente preparato. A scanso di dare l’impressione di un approccio eccessivamente superfluo alla questione, tuttavia, valeva la pena aprire una piccola parentesi al riguardo.
2* Dopo un periodo difficile, Yoshiro Kimura è riuscito a riaffermarsi fondando lo studio Onion Games grazie al quale, tra l’altro, è riuscito a pubblicare la riedizione di Moon: Remix RPG Adventure nel 2021.
3 È doveroso sottolineare come il “bacio” non sia da intendere in chiave erotica o sessuale, ma semplicemente come uno schiocco di labbra innocente con cui il protagonista dovrà riuscire a conquistare l’affetto e l’amore degli svariati personaggi fuori dal comune quali pali della luce animati, creature del soprannaturale e strani esseri sotterranei diffusi per la città (oltre ai personaggi umani). Questa meccanica è derivata dal fascino che Kimura provava verso questo gesto molto diffuso in altri Paesi del mondo rispetto al Giappone, dove invece è considerato un’invasione dello spazio personale inappropriata.
4 Tao è anche il nome del cane di Kenichi Nishi e fa diverse apparizioni nelle sue opere. Purtroppo è venuto a mancare nel 2009, ma grazie ai videogiochi si può dire che abbia raggiunto l’immortalità.
5 Il titolo al momento non è ufficialmente reperibile in alcun modo, ma nulla a cui l’ottimo emulatore Dolphin non possa rimediare.
6 Jenny, tra l’altro, la ritroveremo ormai adulta nel seguito per Nintendo DS 「おかえり!ちびロボ! ハッピーリッチー大そうじ!」 (“Okaeri! Chibi-Robo! Happy Rich Oosouji!”). Il titolo non è mai stato pubblicato ufficialmente al di fuori dal Giappone, ma è disponibile in rete una traduzione in lingua inglese realizzata da terzi. Sono anche stati pubblicati altri titoli in seguito con Chibi-Robo come protagonista, ma non diretti da Kenichi Nishi. Non è un caso che si siano via via allontanati dallo spirito originario, se non abbandonandolo del tutto. Il punto più basso probabilmente è Chibi-Robo! Zip Lash, un platform con ben poco da dire e in cui figura addirittura una marca di caramelle realmente esistente.
COMMENTA SU TELEGRAM
SUPPORTACI SU KO-FI
Perché continuo ad amare Nintendo
Perché continuo ad amare Nintendo

Nintendo è senza dubbio una delle aziende più influenti nella storia dei videogiochi. Non dovrebbero servire grandi presentazioni per ricordarla a tutti: fondata nel 1889 come produttrice di carte da gioco, Nintendo ha gradualmente ampliato la sua attività, passando alla produzione di altri giochi da tavolo come shogi e scacchi, transitando poi a giochi elettronici di varia natura, al punto di essere stata la casa produttrici di videogiochi più importante al mondo, e una delle più importanti adesso.
Nei suoi oltre quarant’anni di leadership del settore, Nintendo è rimasta fedele alla sua particolare concezione di videogioco come, in primo luogo, di gioco, coerentemente con la propria storia. Così come accadeva 130 anni fa, quando fabbricavano le loro carte hanafuda, l’obiettivo principe della “grande N” è rimasto quello in primo luogo di divertire.
Con le parole di Nintendo stessa:
We strive to make consumers of all ages smile through unique forms of play that anyone can intuitively enjoy. Our global teams are dedicated to this mission, and it is as much a part of Nintendo’s DNA today as in the past.
Shuntaro Furukawa, Presidente Nintendo, intervento durante il Corporate Management Policy Briefing, 2020
Ancora più diretta è la sezione “about” del sito Nintendo of America:
“Nintendo’s mission is to put smiles on the faces of everyone we touch.”[1]
Nonostante questa mission così netta e coerente, nell’arco di ormai centotrentaquattro anni di storia, Nintendo ha vissuto più di una contestazione da parte del pubblico. La sua fama di compagnia consumer-friendly è stata spesso messa in discussione, e una certa fetta di videogiocatori vede la casa di Kyoto come un relitto fuori dal tempo. Al contempo, Nintendo persiste nel proprio modo di realizzare le cose, tanto inimitabili quanto, a volte, indecifrabilmente arcaiche. Al punto di sembrare apparentemente non curante della concorrenza, del cambiamento del business, dell’evoluzione del mercato.
In un mondo che corre all’impazzata, la concezione desueta e ipertradizionalista che Nintendo imperterrita porta avanti è spesso guardata con sufficienza, un residuo del passato costretto da sé stesso ad essere meno di quel che potrebbe, bloccando talentuosi developer nello sviluppo di giochi – quando non giocattoli – inadatti al percorso di crescita e sviluppo che il medium sta portando avanti ormai da molto tempo.

Colore, colore ovunque.
Non riesco ad essere d’accordo. In un residuo del vostro cuore, se amate il medium videoludico, un po’ di affetto per Nintendo e la sua storia deve tuttora albergare, ma non deve per forza essere un affetto venato di nostalgia del passato. Personalmente, ho vissuto l’attesa per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con la stessa emozione che ricordo aver avuto per Majora’s Mask più di vent’anni fa. C’è qualcosa nei videogiochi Nintendo che li rende molto più che giochini per l’infanzia, e che lascia la grande N in una posizione di assoluto rilievo storico anche oggi, anche con le sue produzioni attuali. Cercherò di mostrare cosa.
Oltre l’autosabotaggio
Intendiamoci, l’avversione dei videogiocatori per Nintendo non è così agilmente derubricabile a fraintendimento. La principale contestazione alla compagnia riguarda tipicamente la difesa battagliera che la compagnia fa delle proprie IP, considerata eccessiva, frustrante per i consumatori e, in ultima analisi, controproducente.
Il rapporto di Nintendo con le proprie produzioni è effettivamente piuttosto sui generis. Le origini dell’apprensione per la difesa dei propri personaggi possono forse essere fatte risalire alla clamorosa battaglia legale con la Universal [2], che nel 1983 riteneva Donkey Kong un trademark infringement del “loro” King Kong. Nintendo vinse questa causa che si rivelò poi di importanza capitale per la storia dei videogiochi: poter continuare ad utilizzare Donkey Kong di fatto significava poter continuare ad utilizzare Super Mario come personaggio, e non serve specificare l’impatto di quest’ultimo sull’industria.

Donkey Kong (1981) – la causa con Universal è uno spartiacque nella storia del medium.
Una vittoria così decisiva fu celebrata adeguatamente da Nintendo, che addirittura diede ad una sua nuova IP il nome del proprio avvocato difensore nella causa: John Kirby [3]. Dare a un personaggio il nome di un procuratore dovrebbe ben indicare l’atteggiamento di Nintendo sul tema, nonostante due importanti livelli di ironia scaturiti dal fatto in sé. Il primo, naturalmente, è che l’elemento distintivo di Kirby è proprio il copiare le caratteristiche proprie altrui, e non ci sentiamo di escludere in toto una certa malizia in questa scelta. Il secondo, ben più decisivo, è che sembra oggi che Nintendo reciti spesso la parte di Universal, nelle molte cause in giro per il mondo.
La più recente è anche straordinariamente esemplificativa: lo scorso aprile Nintendo è riuscita nell’intento di bloccare numerosi contenuti di uno youtuber, PointCrow, che aveva pubblicato video contenti una versione altamente moddata di Breath of The Wild. Lo youtuber in questione ha quasi due milioni di iscritti, e i propri video superano spesso il milione di visualizzazioni. La foga con cui si bloccano queste esperienze sembra quindi andare anche contro i trend di mercato, con le concorrenti che sono tipicamente ben felici di avere questa visibilità, che costruisce la community e, quindi, nuovi consumatori.

Forse anche io sarei ossessivo con le mie IP, se ne avessi una che supera il miliardo di dollari al botteghino.
Non è evidentemente l’approccio di Nintendo, e la lista di esempi è lunga. Già nel 1989 Blockbuster fu costretta a smettere di fotocopiare i manuali di istruzioni dei giochi NES [4] in quanto la pratica avrebbe violato il copyright, e da allora il numero di casi è lievitato. Un elenco piuttosto bizzarro che non ho intenzione di esplorare oltre.[5]
Insomma, la posizione fieramente arcaica della “grande N” è piuttosto chiara, e il fastidio (quando non l’odio) che ne scaturisce per i videogiocatori è facilmente comprensibile. Sgombrato il campo da dubbi in merito, quello che mi preme raccontare è come, diversamente da quanto spesso viene percepito, questa arcaicità non si ripercuote sul modello di game design, pur rimanendo anch’esso ancorato alla tradizione.
Infantile sarai tu!
La critica a Nintendo è infatti, come anticipato, bipartita. Agli occhi dei critici, esiste da un lato la “Nintendo Corporate”, con le sue pratiche da “boomer” dell’era digitale, e dall’altra la “Nintendo SH”, che ha perso il treno della rilevanza sulla scena per dedicarsi ai suoi giochini, con un approccio infantile, inteso con accezione denigratoria. Ed è qui che perdo il filo.

Cosa c’è di più maturo che sparare ad orridi alieni?
Questa seconda parte della critica è, a mio modesto avviso, un po’ fuori fuoco. Il presupposto implicito è che la fase più strettamente ludica, l’approccio “gameplay-first”, è fuori dal tempo, surclassato da un nuovo standard aureo per cui il videogioco si è emancipato dalla necessità di divertire, forte di una grammatica propria che incorpora gameplay e meccaniche ma che non può risolversi in esse. In altre parole, se abbiamo avuto Kojima forse non possiamo più prendere pienamente sul serio Aonuma; se ho visto la mia violenza in Hotline Miami, forse non ha più senso far combattere due Pokémon per sport. E ancora, dopo aver visto come mi parla Immortality, posso forse accontentarmi di saltare in testa ad un fungo? Dopo essere stato abbagliato dal sublime in Elden Ring cosa potrà lasciarmi la ventosa prateria di Hyrule?
Sono argomentazioni interessanti, ma se assolutizzate rappresentano soltanto una bugia colta. Benché sia certamente legittimo preferire un approccio diverso da quello di Nintendo, infatti, disconoscere in toto il valore di un videogioco integralmente sostenuto dal suo gameplay e dalle sue meccaniche significa avere la pretesa che esista una sola strada, una sola evoluzione coerente con il percorso di crescita del medium.
Non credo sia però corretto ridurre in categorie, derubricare la strada di Nintendo a progetto di Serie B. Più onesto sarebbe piuttosto riconoscere che siamo noi a non avere più interesse in questo approccio, per la nostra storia personale, le nostre attitudini. Nintendo invece, nel focalizzarsi sulla propria mission ricordata in apertura, raccoglie l’eredità della propria storia secolare e la coniuga alle ragioni prime della nascita del videogioco stesso.
Il mondo del gaming è molto grande, abbracciarne tutte le possibili sfaccettature è una gioia. C’è ancora oggi quella fantomatica “Nintendo Difference” promessa, ed è davvero un dono per tutti, anche per chi ha già amato Disco Elysium.[6]
L’eccesso di significante
Non ho veramente interesse a legittimare, ad ammantare di profondità la mia passione per le opere Nintendo. Trovo però che sia opportuno da un lato contestare l’enfasi intellettuale con cui si mette in risalto l’infantilità supposta di Nintendo, e dall’altro sottolinearne la maturità e raffinatezza ludica.
In primo luogo, il concetto stesso di infantilità andrebbe rimesso a fuoco. Personalmente ho un’idea profondamente diversa dell’opera di Nintendo. Per descriverla prendo spunto dalle parole di Robert Walser, poeta svizzero della prima metà del Novecento:
“L’arte non consiste nel dire delle parole, bensì nel formare un corpo poetico, cioè nel far sì che le parole non siano che lo strumento per la costruzione di un corpo-poesia […]”
R. Walser, Briefe
In questo senso, l’arte non è vincolata alla necessità di produrre un senso, poiché l’impegno dell’artista è diretto alla formazione di un corpo. L’arte in questo senso diventa “eccesso di significante” che sembra presentarsi paradossalmente come rinuncia al significato stesso.
L’arte può certamente essere letta puntando al suo significato, ma non è questo ad animarla, o perlomeno non necessariamente. Ritengo non sia troppo diverso nei videogiochi, che perdipiù fra i medium sono quello più strettamente ludico in assoluto. È sotto questa luce che suggerirei di guardare, per esempio, il levigatissimo gameplay di un Super Mario, sicuramente la serie simbolo per eccellenza di Nintendo. La infinita varietà di situazioni, l’impareggiabile level design che esalta il moveset e precisione dei controlli di Mario, si mostrano nel loro esaltante splendore e divertono, trovando in questa progressiva e continua evoluzione degli stessi elementi distintivi dei primi episodi una proprio felice autoconsistenza.
Non è opportuno scambiare questo approccio con infantilità. È anzi piuttosto ingenuo ritenere che il tentativo di mostrarsi maturi sia di per sé stesso l’opposto dell’infantilità. Il pericolo è quello di considerare come meritorio l’utilizzo strumentale del medium videoludico come ennesima via per comunicare forzatamente un’opinione precostituita, di qualunque natura e indipendentemente dal contenuto. Per questa strada l’arte diventa un mezzo per veicolare informazioni; la concezione precede la realizzazione e l’arte si riduce a mera illustrazione.[7]
Questa inversione fra l’apparentemente infantile e l’apparentemente maturo ha in realtà una storia antica, molto più antica dei videogiochi stessi. Un copione non troppo dissimile si è riproposto ciclicamente anche, per esempio, in ambito musicale. Il “pio” quattordicenne Nietzsche rifletteva sulla musica, il cui scopo precipuo sarebbe “guidare i nostri pensieri verso l’alto”; la musica non poteva quindi essere usata per divertimento, anche se “quasi tutta la musica moderna ne mostra le tracce”. La critica ai suoi allora coetanei è quindi che a essi mancherebbero “pensieri propri”, cercando quindi “di ammantare la loro mancanza di idee di uno stile splendido e rutilante”. [8]

Piccolo intervallo musicale.
All’opposto, in età adulta Nietszche celebra la leggerezza della Carmen di Bizet, da contrapporre alla pesantezza dell’opera di Wagner, definita brutale e artificiosa:
Questa musica invece mi sembra perfetta. Si avvicina leggera, morbida, con cortesia. È amabile, non fa sudare. “Il bene è leggero, tutto ciò che è divino corre con piedi delicati”: principio primo della mia estetica.
F. Nietsche, Il caso Wagner, 1888
Tradizione è innovazione
Messi da parte questi distinguo concettuali, una dichiarazione d’amore per Nintendo non può certamente prescindere dal merito ludico, come ampiamente chiarito fin qui. È soprattutto qui, mi perdonerete, che mi commuovo.
La maestria di Nintendo è per l’appunto commovente: la sublimazione della componente ludica già citata non arriva con una perpetua riproposizione del passato[9], ma con una innovazione costante.
Ora, non ho la pretesa che questo sia vero sempre e per tutte le saghe Nintendo. Nel corso del tempo abbiamo visto uscire da Kyoto anche numerosi errori (quando non orrori), veri e propri money grabber, remaster improbabili e quant’altro, senza nemmeno entrare nel merito del servizio online. La colonna portante della storia degli ultimi quarant’anni è però un’altra.
Quando nel 1983 Nintendo lancia il proprio Nintendo Entertainment System (Famicom in Giappone) sta già dando prova della propria portata innovativa. La console avrà il merito di risollevare praticamente da sola l’intera industria da quello che è definito come il “secondo collasso” del mercato dei videgiochi[10]. A dirla tutta, lo fece non tramite una estrema focalizzazione sulla potenza dell’hardware ma concentrandosi su quelli che saranno i propri centri gravitazionali per tutti gli anni a venire: accessibilità, per esempio tramite il rivoluzionario joypad che per primo incorporava una croce direzionale, ed estensione dell’esperienza di gioco, in questo caso per esempio tramite la pistola a fotocellula Zapper che, insieme al gioco Duck Hunt, trasformava la console casalinga in qualcosa di simile ad una esperienza da sala arcade.

Un divertentissimo esempio della “Nintendo Difference”.
Il desiderio di essere sempre per tutti, e sempre per qualcuno in più, sarà la vera stella polare dell’operato Nintendo. Laddove le principali concorrenti attuali sono tech company, Nintendo si conferma una entertainment company [11], interessata non tanto ad innovare verticalmente, sulla tecnologia, ma orizzontalmente, sulle possibilità del medium [12], così facendo allargando ed ampliando un mercato sempre più grande, per il beneficio di tutti.
Questa filosofia sarà particolarmente evidente a partire dal 2006, con il lancio del fortunatissimo Wii, ma è in realtà massima espressione di un’attitudine presente da sempre [13], resa ancor più palese dal contrasto con l’evoluzione lineare dei competitor.
Ambidestrismo magico
L’innovazione lato console, per quanto mirabile, non spiega da sola il successo di Nintendo, e ancor meno spiega il mio amore per loro. Al cuore della questione c’è il software, i giochi, quelle serie leggendarie che ancora oggi stupiscono. I giochi Nintendo hanno più volte contribuito a settare gli standard, sia dei loro generi di riferimento che dell’industria tutta. Il trittico formato da Super Mario, The Legend of Zelda e Metroid, oltre ad essere qualitativamente sensazionale, già negli anni Ottanta fissava stilemi e definiva generi, con impatti che tuttora stiamo riscontrando.
Se Metroid ha dato addirittura il suo nome ad un genere che in tempi più recenti ha visto una sorta di resurrezione, Mario e Zelda hanno collettivamente definito una enorme parte dei mattoncini fondamentali che costituiscono la grammatica del medium, tanto negli anni Ottanta quanto poi con il loro approdo alla tridimensionalità. Per approfondire quanto e come del mondo dei videogiochi sia fondamentalmente indebitato con queste due saghe servirebbero studi dedicati e certamente articoli a parte. Il mio interesse qui è invece provare a sottolineare la grandezza del processo innovativo insito nelle due serie principali di Nintendo.
Il segreto è di quello che nel mondo business verrebbe definito come ambidestrismo. Nintendo, fra un capitolo e l’altro delle sue serie, produce innovazioni verticali (nuovi poteri, nuovi power-up, nuove meccaniche) migliorando costantemente il suo gioco. Nel mentre, assistiamo ad un processo di continua riscoperta dei fattori alla base della grandezza della serie, una perpetua introspezione di Nintendo che viene poi riversata nel capitolo. È questo il paradosso: il feroce attaccamento alle proprie tradizioni e alla propria storia si mescola con l’attitudine a stupire sempre, a ribaltare il proprio tavolo e ricostruirlo partendo dagli stessi pezzi.
Cosa c’è al cuore di Mario
Facciamo degli esempi, partendo in primo luogo da Super Mario. Dal 1985, anno di uscita del primo Super Mario Bros., all’uscita di Super Mario 64 nel 1996, la serie ha sfornato un buon numero di capitoli che continuavano a migliorare verticalmente la stessa formula. Le caratteristiche fondanti rimanevano inalterate: si trattava sempre di platform a scorrimento orizzontale, caratterizzati da numerosi mondi a tema dal tono tendenzialmente scanzonato, una gran varietà di colori e fondali, power up di varia natura e, naturalmente, un level design eccezionale con una pulizia di controlli che ha fatto scuola.
Pur nella stessa cornice i diversi giochi non sembrano mai capaci di stancare, perché le migliorie fra uno e l’altro erano sufficienti a variare la formula per riuscire a generare platform sempre originali, senza mai dare la sensazione di un more of the same, con l’eccezione di Super Mario Bros.: The Lost Levels che aveva in verità il gusto di un moderno DLC e che peraltro non fu commercializzato in occidente, almeno inizialmente.

Quarant’anni e non sentirli.
Con l’avvento del 3D, Nintendo scelse di non difendere una posizione di rendita che sembrava inscalfibile e produsse il nuovo Super Mario 64 stravolgendo i canoni dei platform che lei stessa aveva fondamentalmente creato. La scelta, che oggi sembra ovvia ma che all’epoca rappresentava un enorme balzo in avanti, avveniva a meno di un anno dall’uscita di Super Mario World 2: Yoshi’s Island, l’ultimo capitolo in 2D della serie: un grosso successo di pubblico e critica.
Insomma, Nintendo ribalta il tavolo all’apice del successo, anticipando qualsiasi momento di stanca della serie e realizzando un gioco meraviglioso, un pezzo di storia del medium che fece scuola per la sua capacità di gestire la tridimensionalità e che anche oggi, se rigiocato, non risulta realmente antiquato se non per la sua gestione della telecamera.
Dal 1996 in avanti Nintendo ha quindi dovuto portare avanti due storie, per Super Mario: quella tradizionale, fatta dei rapidi livelli 2D, e quella più recente, la versione nuovamente pioneristica in 3D. Se alla base di entrambe vi erano sempre level design e controlli, è pur vero che la versione 64 introduceva anche elementi che andavano in altre direzioni: Super Mario 64 aveva importanti componenti di esplorazione, soprattutto nel grande hub del castello ma anche all’interno dei livelli, che pure diverse volte provavano a replicare l’esperienza di rapidità e costante movimento dei capitoli originali.

Super Mario 64 ti fa innamorare già nel “tutorial”, quando capisci davvero che cosa hai per le mani.
I successivi capitoli hanno dovuto fare i conti con questa doppia anima. Sunshine (2002) provò ad insistere sulla parte esplorativa, creando un hub ancora più grande e vivo e cospargendolo di segreti, affidandosi poi in toto alle dinamiche date dallo Splac 3000 (la “pistola ad acqua”; uno strumento principalmente esplorativo) e relegando la componente più puramente platform a sezioni brevi e marginali nel più ampio contesto. A mio parere, pur trattandosi di un gioco comunque molto divertente, Sunshine è forse quello che meno cattura l’essenza di Super Mario, e dunque meno riuscito.
Probabilmente simili ragionamenti li fecero anche in Nintendo, ed è qui che partirono con l’introspezione. Cospargere di segreti una enorme area 3D del gioco era davvero necessario? O forse l’esplorazione era una felice aggiunta al contesto e non il nuovo contesto? Dal 2002 in avanti, La casa di Kyoto portò avanti una rifocalizzazione della serie, restringendo progressivamente la hub e lavorando su rapidità e varietà di livelli e situazioni, con i due eccezionali Galaxy [14], mentre parallelamente provava a riprodurre integralmente la formula 2D, con New Super Mario Bros. e i Super Mario 3D. Se i “New” erano una riproposizione piuttosto acritica, i “3D” colgono il segno, restituendo precisamente l’esperienza anni ’80, fatta unicamente di salti millimetrici e corse contro il tempo, ma in un contesto in cui la tridimensionalità degli spazi aggiunge valore all’azione e non resta mero vezzo estetico.
Super Mario Odyssey (2017) è quindi il punto di arrivo di un percorso molto chiaro. L’ampiezza e la varietà dei livelli dei Galaxy si fonde alle dinamiche di platform ultra-compatte dei 3D, e genera una sequela di livelli che auto-contengono dei simil-hub e, nella loro estesa apertura, lasciano lo spazio per vivere sequenze puramente “platformiche” in porzioni localizzate della mappa. È l’unione perfetta delle due storie, di Super Mario Bros. e di Super Mario 64, in cui c’è lo spazio per l’esplorazione e la caccia di segreti ma anche per sezioni adrenaliniche e tecniche all’interno di livelli sempre ispirati.

Super Mario Odyssey è il punto di arrivo di un percorso estremamente coerente.
Basta prenderlo in mano per innamorarsene, ed è un testamento alla capacità di Nintendo di divertire unendo l’innovazione continua ad uno sguardo di fiducia alla propria storia, che non è solo una cantina polverosa o una mucca da mungere ma una riserva di valore ed esperienza.
Chissà come fanno.
Ocarina of Time era già un tradimento
Mi chiedo come fanno perché io non sono in grado. Giocando alla serie Zelda, che non nascondo essere la mia preferita in assoluto, vedevo anche io i problemi sempre più evidenti ma non riuscivo a spiegarmeli, a trovarne una causa [15]. Anche in questo caso, me l’ha mostrata Nintendo stessa, tornando sui suoi passi.
Partendo da presupposti simili ai Mario, gli Zelda hanno avuto più di un inciampo nel corso del tempo, forse perché la sua essenza era più nascosta, o meno focalizzata. Uscito per NES nel 1986, The Legend of Zelda era un meraviglioso videogioco che incorporava elementi action/adventure e RPG in un overworld enorme ed aperto, cosparso di dungeon intricati e ricchi di puzzle e nemici di abbattere. Anche in questo caso il salto al 3D ha prodotto un pezzo di storia importante, quell’Ocarina of Time (1998) che molti fan di Zelda spesso considerano tuttora il miglior videogioco della storia. Naturalmente sbagliano di grosso.

Forse il frame più famoso della serie.
Intendiamoci, Ocarina of Time è davvero un gioco maestoso. Inoltre, è un altro pezzo fondamentale della storia del medium, con una legacy colossale, talmente grande da essere difficile da tracciare. Il mondo di gioco era sì enorme, divertente, bello da vedere e ricco di personaggi memorabili. Viaggiare per quell’Hyrule era davvero una emozione, un privilegio. Già allora però Ocarina of Time pagava un pegno al 3D che Mario non si trovò mai a dover pagare. Ocarina of Time è una trasposizione 3D degli originali in 2D, laddove Super Mario 64 era un ripensamento della serie. E nel scegliere gli elementi da trasporre, nell’identificare il cuore della serie, in origine Nintendo fece un po’ di confusione, prendendo puzzle e convenzioni e non la libertà di esplorare e scoprire un mondo di gioco.
Ocarina of Time è meraviglioso, ma anche il suo bellissimo mondo di gioco non è in realtà un “mondo” come lo era in The Legend of Zelda, bensì un elaborato marchingegno reskinnato, un labirinto in cui si susseguono serrature da aprire con la giusta “chiave”, che a volte sono le effettive chiavi dei dungeon e altre sono oggetti. Un palo di legno è una serratura, e richiede un hookshot come chiave; un masso è una serratura e, a seconda del colore, potrò mettere la relativa chiave, sia essa una bomba, un martello o dei guanti magici. In questo senso, Ocarina of Time è facilmente intellegibile, e quindi non misterioso.

La prima vista dell’Hyrule Field in Ocarina of Time è comunque memorabile.
In seguito a Ocarina of Time, le convenzioni si ripeteranno sempre di più ritorcendosi su sé stesse, i puzzle ambientali saranno sempre intimamente gli stessi, e la serie finirà immersa in una sorta di dimensione parallela, una sacca fuori dal tempo. Una sacca da cui usciranno anche delle perle, intendiamoci. Majora’s Mask, pur frainteso in un primo periodo, sarà un gioco clamoroso, la cui cupezza e il cui brillante utilizzo del tempo metteranno in ombra qualsiasi limite. Anche The Wind Waker, complici uno stile grafico mirabolante e il suo tentativo di utilizzare l’oceano come chiave per la costruzione di un mondo vivo, riuscirà nell’intento di portare un po’ di magia ad Hyrule.
Oltre The Wind Waker, Nintendo perse le fila. Twilight Princess (2006) fu già un tentativo di rimessa a fuoco, ma gravemente fuori strada. Provando a ripensare alle caratteristiche primigenie della saga, finì invece per esacerbare i limiti di Ocarina of Time, velandolo di una maturità fuori luogo, e quelli che erano sassolini divennero massi ciclopici. Ancora più puzzle ambientali, ancora più dungeon e convenzioni desuete e colli di bottiglia, ma sempre meno libertà e un mondo svilito, che cade già al paragone con Ocarina.
Se nel 1998 per raggiungere il deserto avrei avuto la necessità di liberare un cavallo, prendere la rincorsa e saltare un ponte, per poi farlo ricostruire, in Twilight Princess ci vengo sparato con un cannone, arrivando in un’area isolata e sconnessa dal resto dell’overworld. Sempre più serrature, sempre più chiavi. Ocarina of Time era una pietra miliare per tutti, Twilight Princess era un gioco per fan, un anacronismo. E per quanto riguarda Skyward Sword, mi limiterò a dire che in esso almeno si colgono veri tentativi di ripensamento, per quanto nuovamente falliti.

Bell’idea davvero grazie mille.
Raccontare i fallimenti di Nintendo nel ripensare Zelda serve però ad esaltare la grandezza di quando il tentativo è invece riuscito. Come per il recente scudetto del Napoli, una lunga attesa costellata da insuccessi dolorosi rende ancora più dolce la vittoria, ancora più evidente l’amore.
Perché The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) è questo, è la più grande vittoria di Nintendo, e rispecchia di nuovo i canoni descritti in apertura: da un lato l’innovazione tecnologica, ovvero il nuovo motore fisico, dall’altro la riscoperta della grandezza del passato: mondo di gioco e libertà, finalmente ripensato per il 3D. In questo senso, Breath of The Wild è l’equivalente di Super Mario 64 per gli Zelda.
Abilitato da un motore fisico eccezionale, che permette la generazione di numerosi sistemi e lo sviluppo di gameplay emergente, la nuova Hyrule è viva e sempre nuova, non è più intellegibile a prima vista. Le modifiche sono anche concettuali: via gli oggetti da recuperare (sono finite le serrature!), via la struttura rigida, dentro un mondo apertissimo, gigantesco, approcciabile quando e come si vuole grazie ad un nuovo set di poteri disponibile praticamente da subito e alla barra della stamina, che permette di arrampicarsi.
Di per sé, si tratta di un lavoro di decostruzione della saga, effettuata rimuovendo l’inutile, alleggerendola da polverosi dungeon, dimenticandosi della confusa timeline e lasciando in campo soprattutto il wild, la natura selvaggia da cui Link deve dipendere. La chiesa al centro del villaggio. Di nuovo, la riscoperta della storia e di sé come trampolino per la proiezione nel futuro.[16]
È una gioia, questa riscoperta, ed è per questo una gioia anche il risultato: un gioco clamoroso, tuttora inimitato, dalle potenzialità immense. Forse anche per questo, una parte di fan non l’ha capito. Abituati alla propria nicchia autoreferenziale, si sono alzate molte critiche, alcune certamente legittime e altre meno, in primis focalizzate sul basso numero di dungeon e, soprattutto, sulla distruttibilità delle armi. Ma non fa niente, Nintendo ha già pronto il prossimo passo.
E così, eccoci a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Quest’articolo è stato programmato per il dodici maggio 2023, giorno di uscita del seguito diretto di Breath of the Wild. Celebrare Nintendo in questo giorno è di fatto l’obiettivo di questo mio indegno pezzo[17]. Mentre scrivo, non ho ancora giocato a Tears of The Kingdom, ma alcuni semi di novità, coerenti con il percorso descritto, si vedono chiaramente già dal materiale a disposizione.
Innanzitutto, da quanto visibile, Nintendo sembra spingere sul pedale della libertà. Mentre per via del riutilizzo di asset, mondo e motore fisico di gioco alcuni osservatori isolati hanno invocato il “more of the same”, Nintendo ha invece scelto di aumentare esponenzialmente l’interattività, e quindi la dipendenza, con l’ambiente. Laddove Breath of the Wild era un action/adventure con elementi sandbox, sembrerebbe che in Tears of the Kingdom la parte sandbox, e quindi la parte in mano alla libertà del giocatore, sia stata incentivata. Anche in questo caso, Nintendo sembra aver fatto tesoro dell’esperienza data dal precedente capitolo, andando ad esaltare il meglio del proprio titolo.

Non vedo l’ora di giocarci.
In secondo luogo, non posso che sottolineare la maternità di Nintendo nel rispondere alle esigenze dei fan. Nell’aumentare la dipendenza ambientale la grande N viene anche incontro ai critici del sistema di distruttibilità delle armi, che è oggi incorporato negli elementi sandbox grazie al nuovo set di poteri che permette di combinare e rinforzare le armi per potenziarle.
Questa particolare scelta sembra il miglior esempio possibile dell’oculatezza di Nintendo. La critica alla distruttibilità delle armi era, il più delle volte, completamente fuori fuoco: tale feature era assolutamente indispensabile a creare quella dipendenza di Link da Hyrule, che tramite armi e ingredienti gli forniva gli elementi per sopravvivere e contemporaneamente lo incentivava a esplorare luoghi reconditi. Eliminarla poteva significare tornare al sistema di oggetti, alle convenzioni da sacrestia di Twilight Princess. Senza distruttibilità, insomma, non poteva esserci Breath of the Wild.
Nonostante questo, Nintendo ha ascoltato i propri fan, ed è andata a lavorare per migliorare questa sfaccettatura. Non eliminandola, ma scommettendoci sopra, ricostruendo una nuova meccanica che potenzia la propria visione senza scendere a compromessi, e al contempo andando a limare un concept che per molti era un limite del gioco originale. Un approccio folgorante.
Sarà sempre questo, quello che chiederò a Nintendo. Di folgorarmi con una trovata delle loro, di guardare più avanti di me e della mia limitata visione, ma al contempo di pensare a me. Lo avete mai chiesto a qualche altra Software House?
FSF
NOTE:
[1] https://www.nintendo.com/about/
[2] Per approfondire, si consiglia il video-essay al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=i13hrynnGNY
[3] Sulle origini di Kirby si consiglia l’approfondimento su Kotaku: https://kotaku.com/the-accidental-origins-of-kirby-1794773483
[5] Per un elenco comunque non esaustivo: https://www.thegamer.com/the-dungeons-dragons-movie-is-a-blueprint-for-adapting-breath-of-the-wild/
[6] Cioè tutti, spero. Chi è che non ama Disco Elysium?
[7] Per approfondire questa concezione si consiglia “Le non cose: Come abbiamo smesso di vivere il reale” di Byung-chul Han, 2022.
[8] Friedrich Nietszche, Scritti giovanili 1856-1864.
[9] Ok, magari un pochino con Pokémon lo fanno.
[10] Cfr. Conoscere i videogiochi. Introduzione alla storia e alle teorie del videoludico, di M.Pellitteri e M.Salvador, Tunuè, 2014, pag. 40-45.
[11] Nelle parole dell’allora presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime, in questa intervista del 2018.
[12] Che, intendiamoci, utilizza anche l’innovazione tecnologica, ma come strumento e non come fine.
[13] Un’attitudine che continua imperterrita, con Nintendo che si è buttata poi su console ibride (Nintendo Switch), mobile gaming (Super Mario Run, Fire Emblem Heroes…), realtà aumentata (Mario Kart Live: Home Circuit) e su Nintendo Labo, un misto fra gioco fisico e digitale a cui personalmente non so dare una definizione congrua.
[14] Personalmente, i miei preferiti.
[15] Altri invece vi sono riusciti con il giusto anticipo. Per esempio Tevis Thompson, in questo lungo blog che, pur con degli estremismi non condivisibili, c’entra il cuore del problema, ed è una fonte fondamentale del paragrafo.
[16] Un simile tentativo di decostruzione e ricostruzione degli elementi fondativi di Zelda è stato anche realizzato in Tunic, di Andrew Shouldice.
[17] Rigorosamente a titolo gratuito.
COMMENTA SU TELEGRAM
SUPPORTACI SU KO-FI
The Last Express: plus ça change…
The Last Express: plus ça change…

Parigi, primi anni novanta. Un giovane newyorkese si gode un periodo sabbatico studiando cinema, girando documentari e innamorandosi dell’Europa. Un’amica e collega, raggiungendolo dopo un viaggio notturno in treno da Berlino, interrompe il suo idillio con queste parole:
Tomi […] suggested to me the idea of doing a game that was set on a train. […] She evoked the idea of a train standing in a station at night and said: Look, that’s European 20th century history at a glance1.
Jordan Mechner
Se si potesse racchiudere in un unico aneddoto un’opera complessa come un videogioco, questo appena citato sarebbe la perfetta rappresentazione di ciò che è The Last Express: un’intuizione avuta in uno stato di particolare grazia, macchiata però da una hybris spensierata.
Prince of the Lost 48K
Jordan Mechner comincia a realizzare videogiochi da giovanissimo e in completa autonomia, come tanti altri esponenti della scena garage del periodo. Apple II, la sua piattaforma di riferimento, sarà al tempo stesso casa e maestra: le limitazioni hardware gli insegneranno il game design.
Quelle, e i film.
Il suo desiderio è infatti di riuscire a trasporre il dinamismo del racconto cinematografico nelle proprie opere e Prince of Persia, il titolo che lo porterà al successo, nasce proprio da quest’esigenza. Trovando soluzioni derivative ma geniali e costretto a lavorare di sottrazione, Mechner è tra i pochi designer dell’epoca capaci di utilizzare i verbi del gameplay per raccontare una storia. A testimoniare l’unicità del gioco sarà la nascita di un filone detto “cinematic platform” che però produrrà pochissimi equivalenti (Another World di Érich Chahi e, solo a distanza di molti anni, Limbo e Inside di Playdead).
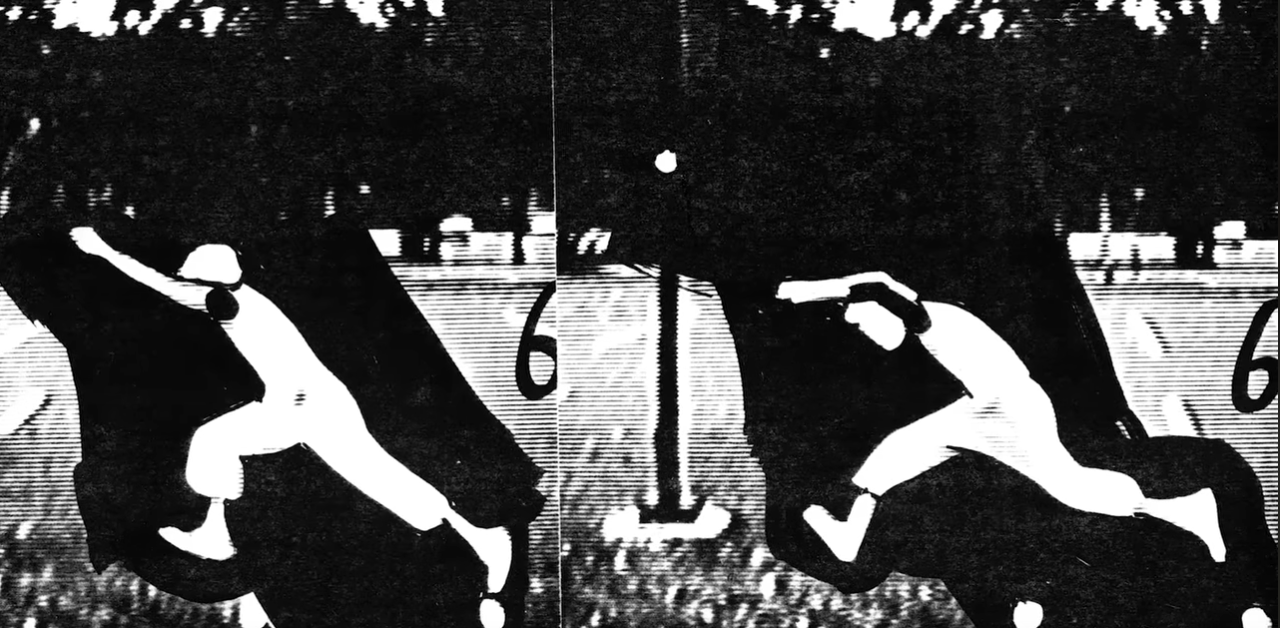
“I took the videotape of my brother and put that on a TV screen in darkened room. Put a 35mm camera on a tripod, aimed it at the TV screen and then took a picture, did a frame advance on the VCR, took another picture, frame advance, frame advance, frame advance. Then I took that roll of film containing about 35 frames down to the local Photomat […] (2)”
Finito il college e forte dei guadagni e delle royalties ricevute Mechner decide di staccarsi dal mondo dello sviluppo, che lo ha tenuto impegnato nei dieci anni precedenti, per dedicarsi ad altre sue passioni. Questo fino a quando non verrà coinvolto nel “fatal incontro” citato nell’introduzione, una spinta ricevuta in un momento preciso della sua vita che lo porterà ad azzardare su tutto, dai temi al design alla produzione.
Smoking Car
Con i fondi rimasti a disposizione Mechner e pochi collaboratori cominciano a dedicarsi in modo ossessivo al nuovo progetto, un gioco ambientato sull’Orient Express durante la sua ultima corsa avvenuta a pochi giorni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Si decide di essere il più possibile fedeli nella ricostruzione ambientale, riuscendo a mettere le mani su tantissimo materiale che si pensava fosse andato distrutto ma che viene invece recuperato tramite un gruppo di ferrovieri in pensione. Si renderizzano mappe originali, menu e suppellettili del vagone ristorante, lo stesso treno sarà ritrovato in un deposito ad Atene e catalogato in ogni sua parte con centinaia di fotografie.
Questa meticolosità costringe il team a cercare molto presto dei finanziatori e a dover aumentare l’organico fino a sessanta elementi, un numero decisamente importante rispetto alla media degli studi coevi.

The Last Express (1997). A sinistra i dipinti di Alphonse Mucha usati come riferimento per disegnare i personaggi, a destra le prime prove di trucco (immagine di Veronika Zýková, “Story was of first importance”, 25fps.cz, 2012)
La lavorazione è caotica ma salvata da felici intuizioni e colpi di fortuna. Basti pensare che prima ancora di avere un impianto di gioco definitivo vengono effettuate due settimane di riprese, con circa trenta attori, per realizzare tutte le animazioni e le scene d’intermezzo. Questo approccio decisamente inusuale viene però gestito con maestria. Scegliendo per la rappresentazione dei personaggi uno stile Art Nouveau ispirato tanto a Mucha quanto a Toulouse-Lautrec, nonché a disegnatori di Bande Dessinée come Schuiten o Giardino, si opta per una soluzione ibrida.
Per ricreare un effetto pittorico le animazioni sono composte da singoli frame, in modo da poter usare il girato a seconda delle esigenze. Altra accortezza è quella di non aver previsto nessun lip synch, così da non essere costretti dal doppiaggio e lasciandosi la possibilità di cambiare elementi di trama in ogni momento. Gran parte dello sviluppo prosegue costantemente su questo delicato equilibrio, tra ingegno e sregolatezza.
A stranger in every seat
Tanta attenzione nel riprodurre il contesto è una precisa scelta artistica di Mechner che vuole mettere in scena, citando Dumas come ispirazione3, una base credibile e storica per rafforzare una narrazione fictionale.
The Last Express inizia in medias res con il giocatore che si trova, senza nessun punto di riferimento o conoscenza del proprio ruolo, a interpretare un personaggio di cui non sa neanche il nome e che è subito coinvolto nella risoluzione di un omicidio. È in questo modo che si introduce una delle meccaniche principali, cioè l’investigazione. Anche se ascrivibile al genere delle avventure grafiche TLE non ne presenta le caratteristiche ritenute canoniche fino a quel momento, come enigmi ambientali o legati alla gestione dell’inventario, ma fa dell’osservazione logico deduttiva degli altri passeggeri e il confrontarsi con loro, oltre che al frugare tra i loro beni personali, il fulcro del gameplay.

Il principale antagonista è la gestione del tempo, che scorrerà indipendentemente dalle azioni compiute. Tutti gli NPC hanno specifiche routine di comportamento legate all’orario, così come il treno proseguirà la sua corsa in modo inevitabile. Sarà quindi compito del giocatore capire, ricominciando più volte o utilizzando una funzione di rewind (che avrà importanza ancora maggiore nell’opera successiva di Mechner, Prince of Persia: The Sands of Time), dove e quando farsi trovare per ottenere il finale più soddisfacente o per scoprire tutti i segreti dell’Orient Express.
La signora scompare
Tale impostazione prevede quindi una grande attenzione nella scrittura dei comprimari ed è qui che si incontra il principale difetto del titolo. Trovandosi a tre giorni dallo scoppio della Grande Guerra, il treno viene utilizzato come metafora sociale di classe e come rappresentazione di un destino ineluttabile. I suoi occupanti non sono altro che l’espressione della situazione europea prebellica: un industriale tedesco diventato ricco con il commercio di armi, un nobile russo che ha ripudiato tutto per abbracciare l’ideale anarchico e in aperto contrasto con un Conte filo-zarista, un gruppo di rivoluzionari serbi appartenenti alla Crna Ruka coinvolti nell’attentato all’Arciduca Francesco Ferdinando, e molti altri.
A fare da collante a tutte queste storie sarà Robert Cath, il nostro avatar: medico statunitense, poliglotta, un “agente del cambiamento” che con le sue capacità porterà ordine in questo microcosmo composto non esattamente da stereotipi ma più da visioni distorte attraverso un inconsapevole orientalismo.

The Lady Vanishes, directed by Alfred Hitchcock
Pur volendo trovare delle attenuanti, dato che il gioco non vuole essere altro che un giallo con richiami ad Agatha Christie o Alfred Hitchcock, la scelta di creare una cornice così complessa lo trasforma inevitabilmente in un’opera politica che però viene banalizzata da un filtro di esotismo contrapposto al pragmatismo occidentale.
One Way
[Attenzione, questo paragrafo contiene spoiler]
La semplificazione dei valori e delle motivazioni che muovono gli attori della vicenda è ben rappresentato dalla storia che coinvolge Alexei Pyotrevich Dolnikov, l’anarchico, e il suo rivale Vassili Alexandrovich Obolensky. La loro faida resta marginale rispetto alla trama principale, almeno fino a quando Alexei non rischia di far saltare tutti in aria con una bomba. Il suo piano viene sventato da Robert, il quale ne deride anche gli ideali e la dedizione a una causa, mentre nel frattempo si prodiga a curare lo zarista con un magico infuso indiano. La tranche narrativa si chiude con un monito alla Russia che:
“[…] must open up to the world if she wants to survive”
George Abbot, “The Last Express”
sottolineando come debba abbandonare ogni cosa per abbracciare, forse, il capitalismo. Tutto si risolve a suon di slogan, in maniera caricaturale.
Altro momento emblematico a sostegno di questa analisi è la forte demarcazione tra ciò che accade prima e dopo Budapest. Gli eventi di gioco si risolvono quasi nella loro totalità e la loro incidenza si riduce drasticamente: ci sarà una lotta con gli indipendentisti, si abbandoneranno i personaggi non più necessari sganciando parte del convoglio e si vivrà l’inevitabile storia d’amore.

Ah, l’amour!
Il viaggio fino a Costantinopoli attraverso i Balcani dura due giorni ma viene rappresentato in soli due minuti, stridendo con la più volte sottolineata attenzione ai dettagli. Fino a quel punto si è seguito in modo precisissimo l’originale itinerario dell’Orient Express, il gioco stesso ci informa volta per volta dell’ora e del luogo esatti (24 luglio 1914: 19:39 Parigi, 21:16 Eperney, 21:41 Shalon-sur-la Marne, 03:38 Strasburgo; 25 luglio 1914: 10:18 Monaco, 12:45 Salisburgo, ecc.). Varcato il confine ungherese i serbi, con il loro dirottamento, introducono però una forza irrazionale che in qualche modo cancella tutto questo. Il treno non farà più fermate e il tempo diventa irrilevante, quasi a voler indicare l’Oriente come regno ‘libero” e terra di piaceri esotici, che si contrappone all’ossessione occidentale per la puntualità come segno di modernità e sviluppo4.
Nel suo libro “Inventing Ruritania: The Imperialism of the Imagination” Vesna Goldsworthy ci ricorda le parole di Jonathan Harker, l’eroe di “Dracula”, che mentre attraversa lo stesso territorio confida in una precisione degli orari tipicamente vittoriana chiedendosi:
It seems to me that the further east you go the more unpunctual are the trains. What ought they to be in China?5
Jonathan Harker
TLE presenta un’analogia simile, con i Balcani visti come luogo in cui la logica scompare e in cui ci si può lasciare andare liberamente all’amore. I sentimenti prendono spazio e per un breve momento si può fingere di essere qualcun altro.
L’omicidio trova una soluzione “realistica” tra Monaco e Vienna, mentre il finale a Costantinopoli introduce ulteriore esotismo facendo sconfiggere l’ultimo nemico attraverso l’ipnosi e inserendo un elemento esoterico fuori contesto. Se l’omaggio a “Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark” e alla scena dell’Arca dell’Alleanza è evidente, essendo questo un film a cui Mechner è molto legato e fonte di ispirazione anche per il precedente Prince of Persia6, i richiami alla novella russa del Principe Ivan alla ricerca dell’uccello di fuoco non fanno che rimarcare la convinzione di Est come terra del fantastico.
Golden Age
C’è però un ulteriore tematica degna di attenzione, quella della nostalgia. Si percepisce infatti un’affezione verso un’idealizzata età dell’oro prebellica, intesa non come periodo di megalomania o grandeur, ma come momento di globale tendenza verso il Modernismo. Il treno/microcosmo ci ricorda infatti di un momento in cui tutti l’umanità si è trovata insieme, percorrendo una strada inevitabile ma ancora piena di speranza nei confronti del futuro.

L’atomizzazione dei nostri giorni non ci fa rendere conto di quanto la felicità sia collettiva e non individuale, come decenni di dogmi neoliberisti ci hanno insegnato7. Ce ne accorgiamo solo quando un cataclisma, che sia una guerra, una pandemia o una crisi ambientale, sta bussando alla porta.
E allora, per quanto possano essere naif, i personaggi diventano in alcuni momenti persone verso le quali si prova una naturale empatia perché a loro, come a noi, è stato tolto qualcosa.
Ironico che queste sensazioni si trovino nelle storie secondarie che lambiscono marginalmente il percorso del protagonista, in fondo anche lui una vittima di se stesso e della sua “way of life”.
… plus c’est la même chose
The Last Express esce nel 1997, dopo cinque anni di lavoro. Per una serie di contingenze, tra cui la pessima situazione finanziaria del publisher Brøderbund, il gioco non viene pubblicizzato e le copie distribuite sono pochissime. L’investimento di $ 5.000.000, molto alto per l’epoca, rientra solo in minima parte.
Nonostante i limiti, veniali e attribuibili più a delle specifiche influenze culturali tipiche di quel periodo che a mancanze autoriali, è uno degli ultimi esperimenti a grosso budget di un’industria allora ancora capace di prendersi dei rischi. Pochi titoli hanno una così forte impronta espressiva, una precisa direzione artistica tanto cocciuta da sfiorare l’autolesionismo e questo non può che farne un’opera da provare, a prescindere dai gusti.
Come delle scatole cinesi, per continuare a guardare a oriente, giocarlo oggi è come fare un viaggio nel tempo dentro un viaggio nel tempo. Passeggeri affacciati a un finestrino che ci mostra, come nella sequenza dei credits in cui ci vengono fatti vedere su una mappa i cambiamenti geopolitici europei dal 1914 in poi, che più le cose cambiano più restano le stesse.
EF
NOTE:
1, 3, 6 “The Last Express – A conversation with Jordan Mechner”, Stay Forever Podcast, 2019
2 “How Prince of Persia Defeated Apple II’s Memory Limitations | War Stories”, Ars Technica, 2020
4 Vesna Goldsworth,”Inventing Ruritania, The Imperialism of the Imagination”, Hurts, 2013
5 Ibid., pp 97
7 Marcello Tarì, “Non esiste la rivoluzione infelice: Il comunismo della destituzione”, Derive e Approdi, 2017
COMMENTA SU TELEGRAM
SUPPORTACI SU KO-FI
Eternal Darkness non è un gioco lovecraftiano
Eternal Darkness non è un gioco lovecraftiano

Eternal Darkness: Sanity’s Requiem (Silicon Knights, Nintendo, 2002) è un titolo che, come le maledizioni più persistenti e potenti, si manifesta puntuale allo scoccare della mezzanotte fra i discorsi degli appassionati dei videogiochi survival horror. Oppure, immancabilmente, quando si rivangano le memorie della “softeca” del GameCube. Il titolo, caratterizzato da uno sviluppo travagliato che puntava inizialmente a una pubblicazione su Nintendo 64, è ancora conservato calorosamente nella memoria di molti di coloro che hanno avuto il modo e il piacere di affrontarlo. Sia allora, come magari chi in questo momento sta dedicando la propria cortese attenzione a questo articolo, che molto dopo (come chi scrive, su un Nintendo Wii retrocompatibile).

Se avete giocato a Eternal Darkness, probabilmente guardando questa immagine siete già un po’ in preda ai ricordi.
A scanso di equivoci, è doveroso cominciare con una precisazione: questo articolo non si pone l’obiettivo di demolire o sminuire in nessun modo l’opera sviluppata dai Silicon Knights attraverso mille peripezie tecniche, dovute sicuramente anche al cambio di piattaforma in corsa. E se in questo momento stanno riaffiorando in voi dei ricordi positivi della vostra fruizione, vi possiamo garantire che in questa sede sono in ottima compagnia.
Il punto del pezzo è invece un altro. Anzi, duplice. Il primo obiettivo è quello di ridimensionare il termine “lovecraftiano”, spesso attribuito a diversi videogiochi un po’, è il caso di dirlo, a casaccio. Eternal Darkness, probabilmente, è l’esempio perfetto di questa confusione, che ha tra l’altro delle origini e coordinate letterarie ben precise che andremo ad affrontare. Qual è, quindi, la poetica dello scrittore americano Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) e a quale, invece, è più ricollegabile quella che si delinea in Eternal Darkness? Questo è, infatti, il nostro secondo obiettivo in questa sede.
Cercheremo di affrontare il discorso in maniera ordinata richiamando in causa il gioco abbastanza spesso onde evitare di perdere il filo, citando anche qualche estratto dalle numerosissime lettere di colui che è stato spesso soprannominato (come vedremo, a torto) “il solitario di Providence” in alcune antologie.
Ma di cosa tratta Eternal Darkness? Ci pare giusto spendere qualche parola riguardo la vicenda, in modo da permettere anche a chi non l’abbia affrontato di seguire il filo del discorso al meglio ma senza per questo anticipare nulla di importante.

Gli spazi ampi di villa Roivas e una buona gestione della telecamera dinamica rendono le stanze suggestive.
Tutto inizia con un omicidio sanguinoso ed efferato, ovvero quello di Edward Roivas. La nipote Alexandra Roivas, unica parente rimasta, viene quindi contattata dalla polizia nel cuore della notte. Alex salta quindi sul primo volo per recarsi alla villa dove abitava suo nonno, un luogo pieno di oggetti curiosi, libri misteriosi e quadri di famiglia che provocano puntualmente inquietudine nella protagonista. Dopo 2 settimane senza risultati da parte della polizia, Alex si rifiuterà di lasciare la villa senza aver prima svelato il mistero dietro la morte del nonno. Sarà proprio questa magione il teatro centrale del titolo, in cui Alex cercherà di fare luce sul passato della sua famiglia mentre scoprirà, piano piano, contro cosa hanno dovuto combattere di generazione in generazione per salvaguardare l’umanità da minacce oscure ai più. Uno dei punti di forza di Eternal Darkness, probabilmente, è come offre al giocatore la possibilità di controllare non solo personaggi differenti distribuiti nei vari capitoli, ma anche di visitare luoghi ed epoche diverse della Storia. Di più non diremo, perché chi ha giocato sa; chi non ha giocato, invece, è giusto che possa scoprire a tempo debito.
Tornando a Lovecraft, prima di proseguire, vediamo di fare un po’ di ordine nella percezione di HPL nell’immaginario dei lettori. Che tipo di persona era veramente?1
Yrs in Tsathoggua’s name, Tomeron the Decayed2
[ATTENZIONE:questo articolo contiene diverse citazioni in lingua originale inglese non tradotte, in quanto riteniamo che una traduzione non ufficiale imposta da chi scrive potrebbe essere intesa come di parte o faziosa alla luce dello scopo che si pone questo articolo. Si è preferito quindi non manipolare i testi richiamati in questo senso. Buona lettura!]
Quella che avete appena letto è una formula di congedo amichevole di una delle numerosissime lettere scritte da Lovecraft nel corso degli anni in cui mantenne una corrispondenza epistolare attiva (ovvero dal 1912 fino al 1937). Queste missive, scritte fittamente, con molto garbo, affetto e premurosità, erano conservate gelosamente dai suoi amici. Un’abitudine che Lovecraft, una volta scoperta, accolse lusingato con un misto di sorpresa, piacere e, considerando la sua enorme modestia, probabilmente con un sorriso imbarazzato. Come si evince chiaramente dai dati seguenti, Lovecraft non badava a spese pur di mantenere i contatti:
Lovecraft variously gave his daily output of letters at anywhere between 5 and 15; if we assume a middle ground of 8 or 10, we reach some 3500 letters a year; over a twenty-five year period (1912 – 1937) we already reach 87,500 at what is probably a conservative estimate. Of these, it is my belief that no more of 10,000 now survive.
Joshi, T. S., Primal Sources: Essays on H. P. Lovecraft, Hippocampus Press, New York, 2003, p. 30

Queste foto ritraggono HPL in compagnia di vari amici tra cui Rheinhart Kleiner, William J. Dowell, George Julian Houtain, Charles W. Heins e altri. È anche presente la moglie Sonia Greene (scattata probabilmente il giorno del matrimonio) e una sua foto da bambino.
Insomma, dati alla mano è evidente come il cosiddetto “solitario” sostenesse invece una fittissima e ricca corrispondenza, non solo per motivi lavorativi, ma anche squisitamente affettivi. Forse non molti sanno che lo scrittore Robert Bloch (noto soprattutto per il romanzo Psycho, 1959) fu un suo grande amico di penna e, de facto, un suo “allievo” in quanto ricevette da lui, per usare le parole dello stesso autore, “invaluable assistance and advice from the elder writer [Lovecraft] in the craft of weird fiction”3, con tanto di revisioni minuziose e mai dietro compenso.
Per quanto Lovecraft non si fosse mai considerato neppure lontanamente un autore di talento, era sempre pronto a prestare la propria passione per aiutare gli amici. Robert Bloch, che seppe della sua morte solo molto dopo, scrisse che se avesse saputo del suo ricovero si sarebbe trascinato fino a Providence sulle ginocchia, tanto era affezionato a lui. Fu la distanza geografica tra i due, divenuta enorme dopo il trasferimento di Bloch in California, a non farli incontrare mai di persona.
La socialità di Lovecraft non si limitava tuttavia alla sola parola scritta, e in seguito alla morte della madre iperprotettiva, Sarah Susan Phillips, HPL moltiplicò i suoi viaggi (partecipando anche a conferenze) fino all’anno del suo ricovero e dipartita improvvisi il 15 marzo del 1937. Adorava fare lunghe passeggiate nella sua amata Providence, non disdegnava assolutamente la compagnia di affetti e amici e non mancava mai di coccolare e giocare con qualsiasi gatto incrociasse. Tra gli ultimi viaggi probabilmente troviamo quelli che lo portarono a DeLand, in Florida, per mesi interi in compagnia dell’amico Robert Hayward Horlow, con cui scrisse il suo ultimo racconto The Night Ocean (1936).

L’avreste mai detto che l’autore del romanzo “Psycho” aveva preso lezioni da Lovecraft? Ora lo sapete! Nell’immagine, un assorto Anthony Perkins nei panni di Norman Bates, nel film iconico di Alfred Hitchcock (1960).
Ci sarebbe molto altro da dire e citare al riguardo, ma devieremmo troppo dall’intento di questo articolo. Concludiamo quindi questa parentesi di rivalutazione, nonché di scoperta, del carattere di HPL (o Grandpa Theobald, uno dei suoi tanti nomignoli scherzosi che si affibbiava) con un paio di citazioni. La prima dal maggiore studioso di HPL, ovvero Sunand Tryambak Joshi, riguardo le sue lettere:
[…] their extraordinary candor; their abundance of wit, humor, satire and persiflage; and their exhaustive and penetrating discussions of a wide range of topics […] and social trends of the nation and the world. His letters are, in this regard, far more interesting and perspicacious than many of his essays on the same subjects.
Joshi, T. S. & Shultz, D. E., An H. P. Lovecraft Encyclopedia, Hippocampus Press, New York, 2004, p. 154
E infine, scacciamo definitivamente l’immagine di una figura reclusa, grigia e insofferente con questo estratto meraviglioso riguardo il suo, seppur breve, matrimonio con Sonia Greene:
Theobald è finalmente un capo famiglia e (tieni i sali a portata di mano) un fedele compagno della più ispirata, congeniale, intelligente, educata, premurosa e devota fra i mortali e i collaboratori, S.H.G., alla quale si è unito nella venerabile e veramente classica istituzione del Santo Matrimonio!
(PAUSA PER RIPRESA DEI SENSI)
Sì, figlia mia, infine il vecchio signore ti ha dato una nuova mamma!
Lovecraft, H. P., Lettere dall’Altrove: Epistolario 1915-1937, A cura di G. Lippi, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1993, p. 86
Definire il “lovecraftiano”
Ora che abbiamo dato una piccola panoramica più intima di Lovecraft, è giunto il momento di parlare della sua vena creativa per quanto riguarda il gotico e il cosiddettocosmic horror. Il punto fondamentale e che distanzia la poetica di HPL dalla messa in scena di Eternal Darkness è molto semplice. Nel videogioco, infatti, le entità soprannaturali antiche quanto l’universo e che dovrebbero restare sullo sfondo, come minaccia invisibile ma palpabile nonché totalmente disinteressate e indifferenti alla specie umana, si trovano invece in veste di protagonisti della vicenda a tutti gli effetti. Non solo, ma all’inizio della storia arrivano a rivolgersi direttamente a un umano “prescelto” in quella che si può interpretare quasi come una richiesta di aiuto, collocandoli quindi in un uno schema quasi manicheo che si completa una volta aggiunto anche il ruolo dei Roivas, riconducibile quasi a “il bene contro il male”4.

Pious Augustus viene richiamato direttamente dalle entità cosmiche in modo da poterle liberare. Non leggerete mai nulla di simile in un racconto di HPL.
La primissima entità scelta dal giocatore nei panni del centurione Pious Augustus a inizio gioco va a definire, infatti, l’entità malvagia di turno, desiderosa di raggiungere nuovamente la nostra dimensione per trascinarla nel caos. E per combattere questa minaccia in maniera efficace, il giocatore si troverà spesso a sfruttare i poteri ricollegabili all’entità che si trova in una posizione di forza rispetto a quella animata da cattive intenzioni (ci torneremo tra poco). Inutile dire, comunque, come qualsiasi forma di contatto diretto volontario (e quindi figuriamoci patti e dialoghi ulteriori) di questo genere sia un tabù assoluto nella poetica lovecraftiana. Lovecraft stesso si esprime così in una lettera datata 5 luglio 1927, indirizzata al curatore della rivista Weird Tales, in cui accetta di inviare di nuovo il suo racconto The Call of Cthulhu:
To me there is nothing but puerility in a tale in which the human form-and the local human passions and conditions and standards-are depicted as native to other worlds [sic] or other universes. To achieve the essence of real externality, […] one must forget that such things as organic life, good and evil, love and hate, and all such local attributes of a negligible and temporary race called mankind, have any existence at all.
Lovecraft, H. P., Selected Letters: 1925-1929, A cura di Derleth A. & Wandrei D., Arkham House, Wisconsin, 1968, p. 150

La rivista Weird Tales, avviata nel 1922, fu il trampolino di diversi scrittori del genere fantastico e non solo. Su queste copertine campeggiano i nomi di Lovecraft, August Derleth e Robert Bloch.
Eternal Darkness, inoltre, inquadra questi esseri cosmici presenti in gioco sotto certi equilibri di forza e debolezza reciproci. Questa dinamica è innegabilmente legata alle mire squisitamente videoludiche dell’opera e non rappresenta di per sé, chiaramente, un difetto del titolo. Tuttavia, al tempo stesso, non si può negare come questo approccio li renda attori in primo piano di un sistema rigido che potrebbe richiamare quasi la morra cinese. Questo li pone sotto una lente ben diversa rispetto alla poetica lovecraftiana, in cui le entità cosmiche non hanno nulla da spartire con qualsivoglia preconcetto antropocentrico, tanto meno al punto da finire incastrate in uno schema pronto per essere impiegato quasi in un gioco da tavolo (torneremo anche su questo). E infatti, “Lovecraft’s ability to depict the insignificance of the entire population of a planet ushers us into the presence of the cosmic horror” e, grazie a questo escamotage, “he could most powerfully convey the atheistic message that we are in fact insignificant atoms lost in the vortices of a boundless cosmos”5. La fonte dell’orrore quindi è l’alterità più pura e abissale, senza compromessi.
Una poetica, questa, ben lontana dai potenti incantesimi magici lanciati dai vari personaggi (nonché grazie alle rune delle entità cosmiche stesse) per sconfiggere i servitori del “cattivo” in Eternal Darkness. E, al tempo stesso, molto più vicina a giochi come Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (Headfirst Productions, 2005-2006), in cui i concetti di minaccia incombente e di impotenza del giocatore sono resi in modo efficace e, proprio per questo, il tutto si pone più vicino alla filosofia originale di Lovecraft.

Che poi, pensandoci, Call of Cthulhu: DCotE è proprio diverso anche nel tono in generale. Per quanto Eternal Darkness abbia alcune scene che si potrebbero definire truculente, non arriva mai a certi livelli di cupezza. Complice, forse, uno stile grafico e una fotografia dai colori accesi.
Se poco fa abbiamo parlato della morra cinese, ecco che le dinamiche ludiche vengono anche richiamate in questo passaggio dallo stesso studioso S. T. Joshi. Qui fa la prima apparizione anche il nome di August Derleth, uno scrittore ed editore che, anticipiamo, rappresenta probabilmente la vera poetica di Eternal Darkness:
[…] neither Lovecraft nor Smith6 nor Howard7 actually wrote about the various elements [le entità] they borrowed from each other; they employed them merely as “background-material”. It was only Derleth who wrote about these elements, making them the focal point of the story and having no broader aesthetic or philosophical purpose than to expound the Mythos and set up a scenario whereby the Mythos “gods” and other entities go through a series of plausible or implausible actions whose significance do not extend beyond the surface events.
In this sense, the great majority of subsequent writers of the Mythos have unwittingly followed Derleth rather than Lovecraft […] using the Mythos elements as if they were mechanical pieces on a board game.
Joshi, T. S., The Rise and Fall of the Cthulhu Mythos (…), pp. 21-22, sottolineature del redattore
Gli alti e bassi di August Derleth
August Derleth (1909-1971) è una figura a dir poco ambivalente per quanto riguarda la figura e le opere di Howard Phillips Lovecraft. È a Derleth e a Donald Albert Wandrei (1908-1987, anch’egli scrittore, poeta ed editore) che si deve, di fatto, la diffusione postuma in forma di antologie dedicate delle opere e delle lettere dell’autore di Providence tramite la casa editrice creata da loro stessi per l’occasione, ovvero la Arkham House (Wisconsin, 1939). La fondazione di questa realtà fu una scelta dettata dalle circostanze, in quanto gli editori già esistenti dimostrarono di non essere assolutamente interessati al progetto.
I racconti di HPL, infatti, erano fino a quel momento disponibili nelle riviste cosiddette pulp, vendute a basso prezzo e a tiratura economica. Impossibile non chiamare in causa la già citata Weird Tales, in quanto fu l’allora curatore della rivista Farnsworth Wright a inviare a Derleth l’indirizzo di HPL dietro richiesta. E August non si fece pregare, scrivendo a Lovecraft la sua prima lettera nell’estate del 1926. Da allora si avviò un’amicizia scandita da scambi epistolari8 in cui Lovecraft non mancava anche di confidare all’amico i suoi sentimenti nei momenti difficili dovuti ai rifiuti di pubblicazione sulle riviste, fonte di tensioni e di stress. Il 4 marzo 1932, HPL gli scrive che “There are times when the experience of repeated rejections would mean little to me, but other times when the symbolism of the process grated harshly -and now is one of those times.”9

August Derleth, seduto alla sua scrivania tutta particolare.
È interessante a questo punto notare e sottolineare le profondissime differenze che contraddistinguono questi due autori. Innanzitutto, Lovecraft non credeva assolutamente in qualsiasi forma di occulto o fenomeno paranormale, oltre a essere un ateo inamovibile. August Derleth, al contrario, era di fede cattolica, appassionato dell’occulto e sosteneva spesso la plausibilità di qualsivoglia fenomeno paranormale. Non è quindi un’esagerazione definirli agli antipodi, ma ciò non impediva a Derleth di provare comunque una grande ammirazione per Lovecraft (che aveva 19 anni in più sulle spalle), né di scalfire la loro amicizia e contatti.
HPL, a questo riguardo, indirizzò una lettera proprio a Derleth il 10 dicembre 1931, in cui procede a sezionare la questione del paranormale in maniera certosina ed efficace in due punti cardine: (1) l’impossibilità materiale del verificarsi dei fenomeni paranormali e (2) i motivi per cui alcune persone possano sostenere di avervi assistito. Si tratta di un’epistola lunga diverse pagine ed estremamente interessante a più livelli (si accenna anche alla collaborazione tra Lovecraft e Harry Houdini). Trattarla per intero sarebbe purtroppo però controproducente, e ne affidiamo quindi la lettura alla vostra eventuale curiosità. Per dovere di cronaca, riporteremo però l’incipit di questa trattazione:
There are far fewer difficulties in accounting for reported “occult” phenomena than accepting the absurdities involved in belief in human personality apart from the living cellular organism. Thus the question resolves itself into two phases:
I : The utter and abysmal improbability of a non-corporeal human existence.
II : The causes of the perplexing illusions which lead certain persons to believe the extravagant and untenable doctrine of noncorporeal existence.
Lovecraft, H. P., Selected Letters: 1929-1931, A cura di Derleth A. & Wandrei D., Arkham House, Wisconsin, 1971, p. 442
Nella stessa missiva, Lovecraft chiama in causa anche il contatto con la religione in età sensibile come fattore determinante nell’accettazione della plausibilità del paranormale.9

Il gioco mostra più volte il modo in cui le entità sono poste l’una rispetto all’altra in maniera rigida e “ludica”. Questo quadretto è posto nella villa dei Roivas, per esempio.
Tornando alle differenze tra i due autori, esse si ripercuotevano anche nel loro rapporto con la scrittura: Derleth, per usare le parole dello studioso S. T. Joshi, era più spregiudicato e tendeva più alla quantità piuttosto che alla qualità, cercando di pubblicare il più possibile e attraverso canali diversi. Lovecraft, al contrario, era più riflessivo, auto-critico e mite nel carattere. Lo studioso definisce Derleth usando aggettivi quali aggressive, modern, overly self-confident, slipshod (riguardo la sua scrittura “goffa”, poco curata) mentre riserva a HPL il ritratto di un “archaic, gentlemanly, diffident, self-conscioulsy ‘amateur’ writer”.10
Queste divergenze, tuttavia, ebbero delle conseguenze tangibili in seguito alla morte di Lovecraft. Come già discusso, Derleth creò la Arkham House e fece pubblicare i racconti e le lettere rinvenute dell’amico scomparso e, in seguito, iniziò quella che si potrebbe definire un’operazione alquanto discutibile. Da una parte, mise in atto un’interpretazione errata volontaria della visione di Lovecraft per produrre altri racconti e libri al fine di lucrare sopra quegli elementi di orrore cosmico che HPL aveva sviluppato negli anni.
Tutto ciò, di per sé, non sarebbe particolarmente condannabile, in quanto si tratterebbe di una interpretazione personale di un materiale di partenza. Tuttavia, ciò diventa imperdonabile in maniera inoppugnabile nel momento in cui Derleth arrivò ad attribuire certi stravolgimenti a Lovecraft stesso, incapace di controbattere per ovvie ragioni, pur di legittimarli. A questo scopo, Derleth non mancò neppure di inventare confidenze ricevute da Lovecraft per sostenere le proprie tesi, oltre a pubblicare 16 cosiddette posthumous collaborations, apparentemente frutto di uno sforzo condiviso tra i due che, però, non si era veramente verificato. Insomma, nient’altro che una speculazione commerciale ai danni della qualità, della visione e della sensibilità del suo amico scomparso (il cui nome, guarda caso, era sempre messo prima di quello di Derleth quasi a difesa preventiva). Persino il curatore della rivista Weird Tales Wright arrivò ad accusare Derleth di plagio a diversi livelli ai danni di Lovecraft in una lettera di rifiuto per uno dei suoi racconti.11

Pious e un’entità malvagia dimostrano i vantaggi dello smartworking. Battute a parte, inutile dire come questo genere di contatti e alleanze siano tutto fuorché lovecraftiani.
A dimostrazione della malafede di August Derleth, troviamo addirittura una sovrapposizione dell’immaginario dell’orrore cosmico di Lovecraft con le dinamiche legate al cristianesimo, come se egli in vita sua non avesse mai ricevuto chiarimenti al riguardo per iscritto dal diretto interessato. S. T. Joshi manifesta infatti così la sua sorpresa mista a disappunto:
There is no way that anyone could have believed that the Lovecraft Mythos was “basically similar” to the Christian mythos-in other words, that it embodied the battle between “good” and “evil”, with the ultimate triumph of the former”-except by the interposition of the Elder Gods, which were entirely Derleth’s invention and which he introduced as a countervailing force of “good” against the “evil” Old Ones
Joshi, T. S., The Rise and Fall of the Cthulhu Mythos (…), p. 180
Questa citazione è perfetta per avviare la prossima sezione di questo articolo, in cui le inclusioni e variazioni di August Derleth andranno a sovrapporsi puntualmente sugli eventi e il contesto narrativo di Eternal Darkness. Teniamo a precisare come ogni ulteriore puntualizzazione in questo senso non abbia lo scopo di svilire le opere o la figura di Derleth, ma sarà riportata per tracciare i paralleli tra la sua poetica e l’opera dei Silicon Knights. Come chiarito prima da Joshi stesso, molti presero per buone queste deviazioni, rifacendosi quindi inevitabilmente ad August Derleth piuttosto che a Lovecraft (lo stesso concetto di “Mythos” è già fuori dalla giurisdizione letteraria di HPL). Ora che abbiamo le idee un po’ più chiare, torniamo quindi finalmente su Eternal Darkness. Perché è più corretto definire questo survival horror/action-adventure come…
Un gioco “derlethiano”?
Qualche paragrafo fa abbiamo accennato allo schema in cui le entità vengono inquadrate nel titolo, con tanto di rapporti di forza e debolezza reciproci. Oltre alle tre entità presenti in questo cerchio (Chattur’gha, Xel’lotath e Ulyaoth) ne è presente una quarta (Mantorok), con un ruolo a sé stante e posta al centro di esse a livello grafico in una sezione del menu delle rune. In ogni caso, questo equilibrio sottintende dei conflitti tra di esse e in cui la razza umana, evidentemente, gioca un ruolo importante (è pur sempre stato Pious a scatenare il tutto a inizio gioco).

Nel gioco stesso, ogni tanto saremo testimoni di schermaglie tra creature legate a entità diverse, riconoscibili per il colore. Un elemento grafico che ricorda quasi i giochi da tavolo.
Eternal Darkness, inoltre, aggiunge anche una componente quasi elementale (o di affinità) a ciascuna di queste entità. Questo fattore è di natura squisitamente derlethiana. Lo scrittore del Wisconsin, infatti, nel pieno della ristrutturazione in malafede dell’immaginario dell’amico scomparso prematuramente, decise di introdurre forzatamente una dinamica di questo tipo in alcune entità create da Lovecraft e, non contento, ne inventò un’altra legata al fuoco per far tornare i conti. È doveroso segnalare come questa aggiunta sia una pura invenzione di Derleth, spacciata però come lovecraftiana dallo stesso a suo tempo:
One of Derleth’s other conceptions in regard to the Old Ones-that they are elementals-should be addressed. […]
“Nyarlathotep corresponds to an earth-elemental, Cthulhu to a water-elemental, Hastur to an air-elemental, and Shub-Niggurath is the Lovecraftian conception of the god of fertility.” In the introduction to The Dunwich Horror and Others (1963) […] Derleth adds that “I myself added Cthugha, corresponding to the fire elemental Lovecraft failed to provide.” […]
And if, as Derleth repeatedly maintained, Lovecraft was systematically working on the Cthulhu Mythos or the last decade of his life, how could he have been so foolish as to neglect to invent a fire-elemental, forcing Derleth to come to the rescue with Cthugha?
Joshi, T. S., The Rise and Fall of the Cthulhu Mythos (…), p. 183
Oltre al danno la beffa, insomma. In ogni caso, questa immagine di gioco presenta in maniera inequivocabile questo tipo di inquadramento sistemico e rigido in Eternal Darkness.

All’inizio dell’avventura, Pious dovrà raccogliere alcuni artefatti da collocare sotto la runa corrispondente. Il motivo per cui questi elementi vengono ritrovati tanto facilmente potrebbe essere duplice: da un lato, dettato dalla volontà delle entità di facilitargli il compito; dall’altro, forse dovuto alle iterazioni continue fino a progetto inoltrato da parte dei Silicon Knights riguardo il prologo di Eternal Darkness.
Un altro fattore che avvicina Eternal Darkness ulteriormente alla poetica di Derleth è il concetto dello scopo che queste entità in esilio si pongono. All’inizio, Pious Augustus viene richiamato, si presume, da tutte e 3 quelle presenti nella trama, in quanto i loro artefatti (prossimo argomento, tra l’altro) si trovano nella stessa stanza circolare, a brevissima distanza uno dall’altro. Ma cosa anima esattamente queste entità nel voler tornare nella nostra dimensione da cui erano state esiliate? Nulla in particolare, a parte il fatto di voler annientare la razza umana grazie ai loro immensi poteri.
E tuttavia, il desiderio di annientare la nostra specie non può essere concepito senza che ci sia, al tempo stesso, una profonda considerazione, un riconoscimento ufficiale della nostra importanza nell’equazione dei loro piani. Questa dinamica è confermata dall’alleanza di queste entità con Pious (cioè il villain a tutti gli effetti di Eternal Darkness), apparentemente indispensabile per mettere in moto i loro piani.
Tutto ciò, come è facile dedurre, è ben lontano dalla poetica e dall’idea di “entità cosmica” del gentiluomo di Providence, in cui gli sventurati che entrano in contatto con certe verità, incarnate da creature di fantasia, si ritrovano in queste circostanze per casualità o, più spesso, per desiderio degli sventurati stessi. Non esiste, infatti, un solo racconto di HPL in cui figuri un piano malvagio messo in essere dagli “antichi” di qualsivoglia natura. Lo stesso non si può dire, invece, di August Derleth.

Anche una controparte del Necronomicon fa la sua apparizione in veste del Tome of Darkness, anche se in Eternal Darkness ha uno scopo diverso e pare diventare, a tratti, quasi un album di famiglia dei Roivas.
Il concetto di evil viene chiamato in causa da Derleth stesso nel suo racconto The Horror from the Depths, scritto nel 1931 ma rifiutato dalla rivista Weird Tales (probabilmente sempre per motivi di plagio) e apparso solo nel 1940 sulla rivista Strange Stories. In questo racconto, il protagonista ritrova un artefatto/fossile sul fondo del lago Michigan, che poi sarà fonte di guai. Nel racconto, egli scrive:
It was then that he had his first vague knowledge of the Elder Gods, the Ancient Ones, and of those others, mad genii of evil who inhabited outer space before the world was born. It was they who descended to ravage Earth and were vanquished by the Elder Gods, and banished to the bottom of the sea. […]
Professor Holmes finally drew a consecutive and logical story of the age-long struggle between the forces of cosmic evil and the Elder Gods-the final defeat of the Evil Ones, and their ultimate banishment into the far corners of the earth.
The Horror from the Depths, August Derleth
Riguardo questa scelta ben precisa di parole, Joshi interviene sottolineando come “To speak of ‘evil’ without defining how, exactly, the entities in questions are evil (as Derleth never does), aside from their putative harm to the human race, is to set-up a kind of cowboys-and-Indians kind of story” (ibidem). Lo stesso Clark Ashton Smith, grande amico di HPL nonché autore di racconti fantastici che vi consigliamo caldamente, scrisse a Derleth al riguardo invano: “I shouldn’t class any of the Old Ones as evil: they are plainly beyond all limitary human conceptions of either ill or good”12.
Anche le lotte intestine citate nell’estratto del racconto sono degne di interesse, in quanto pure nel videogioco per GameCube è presente la figura della “divinità” (termine usato nel gioco stesso) Mantorok, in grado di contrastare l’entità malvagia di turno. Chissà, forse è proprio Mantorok a essere responsabile dell’esilio dei 3 esseri cosmici citati poco fa (e quindi accomunabile per certi gradi a un elder god). In ogni caso, è evidente come questo intreccio vada a formare uno scenario profondamente derlethiano piuttosto e non lovecraftiano.

Il livello ambientato ad Amiens (Francia) è molto suggestivo e cangiante nel corso del gioco. Al tempo stesso, tuttavia, gli eventi che vi si verificano confermano un’influenza continua tra le entità cosmiche e la nostra Storia, in controtendenza netta con la poetica lovecraftiana.
Non è un caso che, in effetti, risulti piuttosto impegnativo cercare di offrire letture di Eternal Darkness che vadano oltre la mera successione degli eventi mostrata a schermo. Per citare lo stesso Lovecraft, “un racconto fantastico non può & non deve essere un racconto “d’azione” o di “personaggi”. […] Gli avvenimenti non devono essere troppo serrati né i personaggi assumere eccessiva importanza. I veri protagonisti della narrativa fantastica non sono persone ma fenomeni”13.
Tuttavia, come precisato in apertura, ciò non toglie che l’opera dei Silicon Knights rimanga assolutamente godibile e valida sotto altri aspetti (come per molti è stato, noi compresi).
In ultima istanza, vediamo di affrontare la questione degli artefatti già accennata. All’inizio di Eternal Darkness, infatti, il personaggio Pious Augustus si trova a dover sceglierne uno tra 3, ciascuno collegato a un’entità desiderosa di uscire dall’esilio. Una volta compiuta questa scelta, parte del potere elementale (o sarebbe meglio dire di affinità) viene trasferito a Pious stesso, che lo userà per gli scopi malvagi dettati dall’essere di turno.
Il concetto della presenza di artefatti collegati alle entità cosmiche in maniera così intima e diretta (tanto da provocarne il ritorno o l’esilio) è anch’esso legato a doppio filo con la poetica di August Derleth. Lo studioso Joshi suggerisce come ispirazione di questo elemento il tentativo di romanzo di Lovecraft At the Mountains of Madness (1931), e probabilmente non è un caso che l’anno di stesura e pubblicazione sia lo stesso del racconto già citato The Horror from the Depths di Derleth. Nell’opera di HPL, alcuni membri di una spedizione scientifica in Antartide, mentre esplorano alcune rovine sotterranee di una civiltà sconosciuta, a un certo punto ritrovano degli artefatti a 5 punte dall’aspetto curioso. Il seguente estratto dell’opera sottolinea, inoltre, la volontà di inserire, a tratti, un registro asciutto e scientifico per la descrizione dei reperti ritrovati:
Have found peculiar soapstone fragment about six inches across and an inch and a half thick, wholly unlike any visible local formation. Greenish, but no evidences to place its period. Has curious smoothness and regularity. Shaped like five-pointed star with tips broken off, and signs of other cleavage at inward angles and in centre of surface.
At the Mountains of Madness, H. P. Lovecraft
Questi reperti, tuttavia, nella poetica di HPL non nascondono alcuna proprietà magica o scatenante che ritroviamo, invece, nelle opere di August Derleth e nello stesso Eternal Darkness. Per lo scrittore del Wisconsin, infatti, si tratta di un elemento ricorrente grazie al quale gli Old Ones, imprigionati dalle entità buone Elder Gods, riescono puntualmente a tornare a minacciare l’umanità. Ed è proprio questa la causa scatenante che avvia tutte le peripezie presenti nell’opera dei Silicon Knights: l’esistenza di artefatti legati a divinità malevole, in esilio, in attesa di essere riscoperti dal caso o da qualcuno animato da cattive intenzioni.
Questo elemento di congiunzione rappresenta l’ennesimo punto in comune tra quell’ottimo gioco (teniamo con tutto il cuore a ribadirlo) che è Eternal Darkness e la poetica di August Derleth.
Se siete arrivati fin qui con la lettura vi meritate un premio. Per questo motivo, la prossima e ultima sezione sarà dedicata ai motivi che rendono questo gioco degno di essere provato.
L’orrore attraverso le epoche
Uno degli elementi sicuramente ricorrenti della poetica di Lovecraft, e ancora non trattato, è quello dello scotto che spesso si trovano a pagare i protagonisti dei racconti di HPL quando entrano in contatto con qualcosa che annienta le loro certezze, che ridimensiona improvvisamente il loro ruolo percepito nell’insieme delle cose. In Eternal Darkness, infatti, ogni volta che il nostro avatar si troverà davanti un nemico soprannaturale subirà una diminuzione di una barra speciale14. Sotto una certa soglia, cominceranno a verificarsi conseguenze quali allucinazioni visive o uditive.
Questa dinamica non brilla sempre per originalità, in quanto non disdegna di ricorrere a veri e propri stereotipi del genere horror, ma al tempo stesso i Silicon Knights hanno avuto l’intuizione brillante di coinvolgere il giocatore in modo diretto con un paio di trovate (a voi scoprirle). Degno di menzione, tuttavia, è il fatto che questa barra sarà più o meno capiente a seconda del personaggio e che il criterio, apparentemente, pare sia la propensione o meno a credere ai fenomeni paranormali caso per caso.

Durante i combattimenti, è possibile mirare a parti del corpo precise in maniera molto intuitiva in tempo reale (notare il braccio destro marcato in bianco del nemico) al fine di renderli inermi e più “gestibili”. Probabilmente questo fu uno degli aspetti più impattanti di questo gioco del 2002.
E tuttavia, come accennato già, l’elemento che probabilmente rende Eternal Darkness particolarmente affascinante sono i viaggi nella Storia, nel mettersi nei panni di personaggi diversi ma, alla fine, tutti uniti più o meno consapevolmente nella stessa lotta. A causa dei tempi di sviluppo, alcuni luoghi sono stati riutilizzati, ma puntualmente arricchiti con nuovi luoghi e obiettivi da svolgere; con un po’ di immedesimazione, in questo senso, il giocatore potrebbe fare un piccolo sforzo e cercare di rivivere quelle ambientazioni tramite la percezione nuova dei vari personaggi di volta in volta. L’ambientazione più affascinante, probabilmente, è quella della cattedrale di Amiens in Francia (realmente esistente).
Come ultimissima cosa, non si può non menzionare la gestione degli incantesimi. Tramite un menu apposito, sarà infatti possibile combinare le varie rune per crearne sia di nuovi che versioni più potenti di quelli già scoperti nel corso dell’avventura, con tanto di possibilità di assegnarne fino a 4 in slot “rapidi” in modo da poter essere lanciati semplicemente con la pressione di un tasto.
Insomma, se non avete mai provato Eternal Darkness prima e credete che le sue atmosfere, trapelate dalle immagini usate finora, possano coinvolgervi, vi consigliamo caldamente di dare a questo gioco “derlethiano” una possibilità.
Nessuno può scrivere senza un’autentica spinta emotiva, e io la provo solo nel caso in cui entrino in scena violazioni dell’ordine naturale… […] Niente mi appare veramente drammatico se non un’improvvisa, anormale violazione di ciò che è inevitabile per l’eternità […]. Di qui i racconti che cerco di scrivere. Ovviamente, sono consapevole che questo costituisce un campo molto specifico e limitato agli occhi delle masse: ma credo […] che il genere, nonostante la sua natura minore, abbia una propria autenticità. […] non c’è ragione perché i suoi praticanti se ne debbano vergognare.
Lovecraft, H. P., Lettere dall’Altrove: Epistolario 1915-1937 (…), p. 304
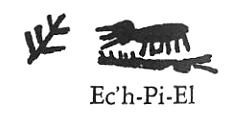
15
LR
NOTE:
1 Nella sezione che segue si è cercato di restituire un’idea meno stereotipata dell’autore statunitense. Gli argomenti più spinosi e controversi quali il razzismo e un certo antisemitismo (che tuttavia non gli impedì di coltivare certe amicizie e né di sposare Sonia Greene) non saranno affrontati, in quanto complessi da snocciolare e contestualizzare in un articolo che già sfiderà (o avrà sfidato) la vostra pazienza. Inoltre, queste forme di discriminazione sono da intendersi come di matrice squisitamente culturale e non razziale. Con l’eccezione, a onor del vero, di quella verso la popolazione afroamericana. In ogni caso, tutto ciò non si tradusse mai in manifestazioni di qualsivoglia violenza nella sua vita: Lovecraft era un uomo mite e cordiale.
La manifestazione di queste tendenze si concentrava invece in un sentimento che potremmo forse identificare come un forte disagio. Ciò che lo turbava era la contaminazione fra le culture, credendo che da questo scontro e incontro ci fosse tutto da perdere per tutte le parti coinvolte. A riprova di questo, in una lettera del 12 giugno 1933 scritta a James F. Morton, tra le molte considerazioni al riguardo (talvolta amare per quanto interessanti a leggersi oggi, non vi è un dubbio), spicca il suo profondo dispiacere per la contaminazione della noble and ancient culture of Japan*. Si pensi, inoltre, al suo amico ebreo di lunga data Samuel Loveman, che rimase all’oscuro di questo lato antisemita di HPL fino al 1947 (ovvero dieci anni dopo la sua morte), nonostante avesse ricevuto da lui circa 400 lettere. Tutte finite, tra l’altro, tra le fiamme, tanto fu amara la sua sorpresa.
*Lovecraft, H. P., Selected Letters: 1932-1934, A cura di Derleth A. & Turner J., Arkham House, Wisconsin, 1976, p. 206
Per ulteriori approfondimenti in questo senso consigliamo la lettura delle lettere stesse, reperibili anche su archive.org nei volumi delle Selected Letters o anche nel volume in italiano Lettere dall’altrove. Entrambe queste fonti sono citate puntualmente in questo articolo.
2 Lovecraft, H. P., Selected Letters: 1929-1931, A cura di Derleth A. & Wandrei D., Arkham House, Wisconsin, 1971, p. 117
3 Joshi, T. S., The Rise and Fall of the Cthulhu Mythos, Mythos Books LLC, Poplar Bluff (Missouri), 2008, p. 140
4 È degno di menzione un finale segreto di Eternal Darkness in cui si svela una dinamica in più rispetto a quelle percepite dal giocatore fino a quel momento. Tuttavia, ciò non toglie che di fatto nell’opera dei Silicon Knights si assista a uno scontro tra “divinità” coadiuvato dall’intervento di alcuni prescelti umani.
5 Joshi, T. S., The Rise and Fall of the Cthulhu Mythos […], p. 19
6 Clark Ashton Smith (1893, 1961).
7 Robert Ervin Howard (1906-1936).
8 A questo proposito, dobbiamo segnalare come siano reperibili alcune fotografie che ritraggono Lovecraft in compagnia di Donald Wandrei, ma nessuna scattata accanto a August Derleth (che invece figura in un’istantanea accanto a Robert Bloch, entrambi del Wisconsin). Stando al volume An H.P. LOVECRAFT Encyclopedia (S. T. Joshi, David E. Shultz, ), tuttavia, fu lo stesso Lovecraft a presentare Wandrei a Derleth. Forse sempre per via epistolare? A scanso di imprecisioni, preferiamo lasciare questa parentesi aperta.
9 “Our minds are crippled – biased and predisposed toward the acceptance of supernaturalism as a matter of course – by the religious instruction we receive at the most impressionable period of early childhood.” (Lovecraft, H. P., Selected Letters: 1932-1934 […], pp. 26-27).
10 Lovecraft, H. P., Selected Letters: 1929-1931 (…), p. 444
11 “But a more serious objection to this story is the fact that you have lifted whole phrases from Lovecraft’s works […]. Also, you have taken the legends of Cthulhu and the Ancient Ones directly out of Lovecraft. This is unfair to Lovecraft. […] My admiration for Lovecraft’s writing amounts almost to idolatry, and I cannot allow such imitation in Weird Tales. […] your usage oversteps the bounds of property”. (Joshi, T. S., The Rise and Fall of the Cthulhu Mythos […], p. 187)
12 Joshi, T. S., The Rise and Fall of the Cthulhu Mythos […], p. 191
13 Lovecraft, H. P., Lettere dall’Altrove: Epistolario 1915-1937, A cura di G. Lippi, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1993, p. 310
14 La barra speciale è in realtà chiamata “barra della sanità mentale”, un terminologia obiettivamente poco rispettosa e insensibile verso tutti coloro che soffrono di qualsivoglia patologia psichica. Col senno di poi, e considerando quanto possono essere transitori i suoi effetti, si sarebbe potuta chiamare in qualsiasi altro modo (per esempio, “barra della tensione”). Non è un caso che il gioco di ruolo Lovecraftesque (Black Armada Games) abbia dedicato un intero capitolo al ridimensionamento del tema della “follia”, dando anche qualche linea guida su come evitare tutti quegli stereotipi a essa legati a cavallo tra il 19° e il 20° secolo.
15 Lovecraft, H. P., Selected Letters: 1929-1931 (…), p. 216
COMMENTA SU TELEGRAM
SUPPORTACI SU KO-FI
Le sberle di Monkey Island sono un atto d’amore
Le sberle di Monkey Island sono un atto d’amore

[DISCLAIMER: l’articolo contiene ampi spoiler su tutta la saga di Monkey Island, compreso l’ultimo capitolo]
Non è un mistero, o non dovrebbe esserlo, quanto la saga di Monkey Island sia stata rappresentativa, nella storia dei videogiochi tutta. Questo è vero in particolare per quel periodo storico che coincide con l’età dell’oro del genere delle avventure grafiche “punta e clicca” e che va all’incirca dalla seconda metà degli anni ’80 alla fine degli anni ’90.
La serie made in LucasArts si inserisce in un ricco filone, erede delle avventure testuali degli anni ’70, fra cui ricordiamo specialmente il seminale Colossal Cave Adventure, del 1976, sviluppato dal programmatore e appassionato di speleologia William Crowther. Il gioco, riconosciuto per la sua colossale influenza1 sul medium tutto, ispirò in primo luogo Infocom e la sua serie Zork2 (1977), e, inoltre, Mistery House3 (1980), la prima avventura grafica (non testuale) della storia e il primo titolo di Sierra On-Line.
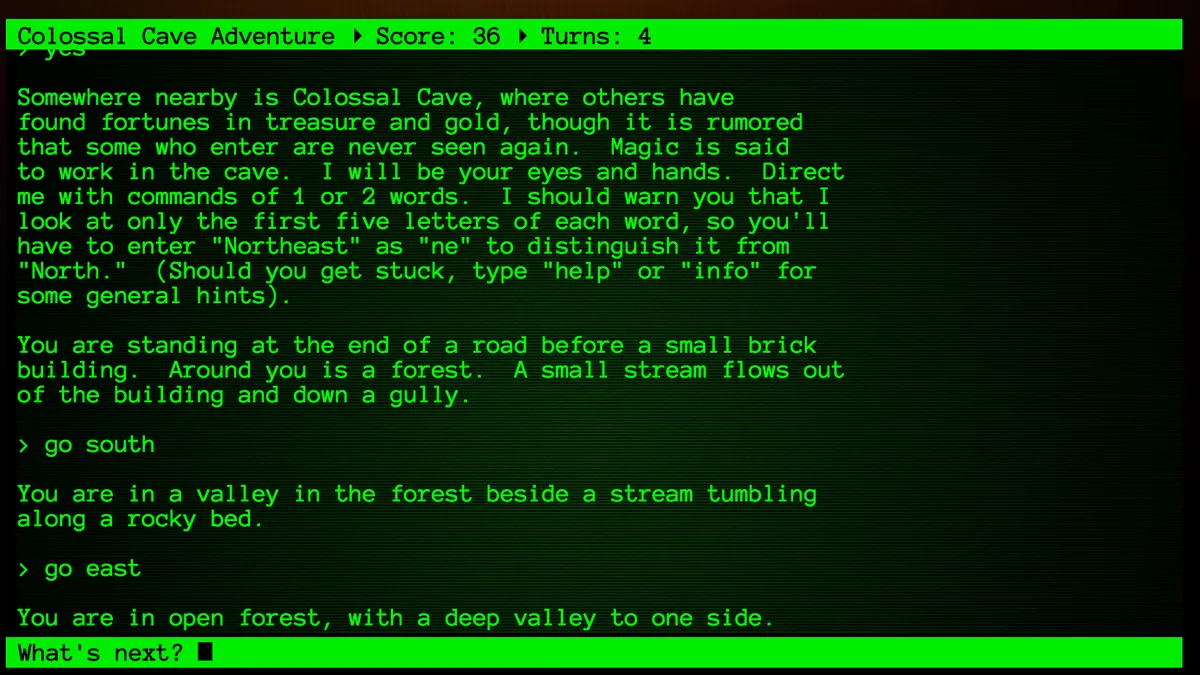
Una schermata di Colossal Cave Adventure, progenitore delle avventure grafiche.
Inseritasi in questo filone costruito di Infocom e Sierra, la già citata LucasArts, fondata dal celeberrimo George Lucas nel 1982 e già spin-off della Lucasfilm, diventerà la più popolare software house del genere, in primo luogo proprio per merito dei primi due giochi della serie Monkey Island. The Secret of Monkey Island (1990) e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge (1991) furono realizzati da Ron Gilbert, Tim Schafer e Dave Grossman, e il loro successo riuscì a travalicare la ben custodita nicchia di appassionati del medium come pochi altri titoli dello stesso oscuro periodo.
The Secret of Monkey Island attinge dalla formula dei precedenti LucasArts4, e aggiunge il suo spin, la sua capacità di giostrare in contemporanea un umorismo soverchiante e un contesto spettrale, attraverso una lunga serie di enigmi in perenne equilibrio fra logica perfetta ed acuta demenzialità. Un flusso continuo e perfettamente calibrato, che nasce dalla esplicita volontà di Ron Gilbert di rendere vivi e esplorabili gli ambienti di una giostra. In un’intervista del 1990, lo stesso Gilbert dirà:
I’d wanted to do a pirate game for a long time. You see, one of my favorite rides in Disneyland is Pirates of the Caribbean. You get on a little boat and it takes you through a pirate adventure, climaxing in a cannon fight between two big pirate ships. Your boat keeps you moving through the adventure, but I’ve always wished I could get off and wander around, learn more about the characters, and find a way onto those pirate ships.
Intervista con Ron Gilbert, estratto da LucasFilm Adventurer vol. 1, numero 1, autunno 1990
Una mirabile operazione di ambidestrismo, destinata a impattare la memoria di una foltissima schiera di giocatori e a diventare un autentico cult.

La gara di sputi di Money Island 2 è un perfetto esempio dell’umorismo che cosparge la serie.
Una bomba ad orologeria
Gli ingredienti, insomma, sembrano già tutti sul tavolo. Un cult degli anni 80/90, un protagonista dall’umorismo indimenticabile come Guybrush Threepwood, la community gamer chiamata in causa, il ritorno in voga della pixel art. Così, quando il 4 aprile 2022, oltre 30 anni dopo l’uscita del suo ultimo Monkey Island, Ron Gilbert annunciò ufficialmente che nell’arco di pochi mesi sarebbe uscito Return to Monkey Island, la risposta del pubblico di affezionati nostalgici non poté che essere esplosiva.
Ad aggiungere benzina sul fuoco, bisogna dire che ulteriori elementi sono andati a soffiare nelle piratesche vele dei nostalgici. Ron Gilbert abbandonò LucasArts già nel 1992, poco dopo lo sviluppo del secondo capitolo, e fu seguito poco dopo da Dave Grossman (1994). Schafer rimase in LucasArts un po’ più a lungo, e sviluppò altre avventure almeno dello stesso livello di Monkey Island (Full Throttle, Grim Fandango), ma durante questo periodo comunque non lavorò più ai restanti capitoli della serie.
Per questo, Guybrush Threepwood continuò le sue avventure senza i propri padri, e agli occhi dei fan questo creò una parabola discendente della serie, se non qualitativa perlomeno in termini di legittimità. La cosa prendeva forza man mano che i titoli si allontanavano dai canoni dei primi due giochi, già a partire dal meraviglioso5 The Curse of Monkey Island (1997).
Il terzo capitolo si allontanava, per ragioni legate alla fisiologica evoluzione tecnologica, dal design pixellato dei primi due episodi, proponendo un’interfaccia ripresa dal già citato Full Throttle in un contesto di luminosa cel animation. Non solo le componenti tecniche: per una precisa scelta ideologica, The Curse of Monkey Island sceglie di trascurare brutalmente il clamoroso cliffhanger alla finedel secondo episodio, che vede Guybrush e la sua nemesi LeChuck apparentemente tornare indietro nel tempo6.

La coloratissima grafica del terzo capitolo in uno dei mitici duelli di spada e insulti.
I successivi capitoli della serie non fecero che aumentare lo straniamento del nucleo di fan più hardcore e restii al cambiamento, complice una qualità – opinione dello scrivente – complessivamente inferiore. Il quarto capitolo, Escape from Monkey Island (2000), si rivelò pasticcione e poco gentile con la lore, mentre il quinto, Tales of Monkey Island, fu sviluppato su licenza da Telltale Games, e benché vide il ritorno di Dave Grossman alla guida non riuscì a svettare rispetto alla restante produzione Telltale, replicandone pedissequamente la struttura episodica.
La nostalgia è una patata bollente
Insomma, in questo contesto esplosivo si profila uno scenario classico: l’annuncio di Gilbert, deus ex machina della serie, scatena reazioni emotive e veementi da parte di una fetta di pubblico un po’ più grossa di quanto si vorrebbe, per via dello stile grafico inatteso e molto lontano dalla pixel art che, orami quasi dieci anni prima, Gilbert aveva ventilato7. È il classico effetto della nostalgia, un sentimento a due facce che tante volte è utile a ricordare quanto di bello è andato perduto e si può recuperare, mentre tante altre è lo specchio di un tentativo di rivivere illusoriamente il passato, incapaci di accettare il proprio presente.
Gilbert, per la verità, la nostalgia la conosce bene. Il suo stesso annuncio, arrivato il 4 aprile, era stato anticipato da un precedente, brevissimo post sul suo blog il 1 aprile, giocando quindi su una running gag che fra i fan durava da ben 18 anni8: l’annuncio di un nuovo capitolo sarebbe stato fatto proprio nella giornata mondiale degli scherzi e delle fake news, in modo da non essere preso sul serio, dopo anni e anni di anticipazioni. Inoltre la precedente opera di Gilbert, Thimbleweed Park, era un gioco platealmente nostalgico e dedicato a ricordare i tempi di Maniac Mansion. Anzi, fu concepito per essere un gioco LucasArts del 1987 ritrovato per caso. Nelle parole di Gilbert:
The point of this project was very much to build a game that was evocative of how you remember the old adventure titles.
Ron Gilbert, intervista a Vice, 11 febbraio 2017

È impossibile non rivedere un po’ di Maniac Mansion in Thimbleweed Park.
Gilbert ama giocare con i punta e clicca, ma evidentemente ama anche giocare con la nostalgia. E allora perché, dopo un gioco in pixel art come Thimbleweed, presentarsi con lo stile grafico animato e sbarazzino e di Return to Monkey Island? Perché un disegno così vivace e “infantile”, quasi da libro pop-up? Un certo insieme di fan, naturalmente, non poteva accettarlo, e dunque non l’ha accettato, reagendo veementemente (e in alcuni casi ferocemente, come solo la rete sa), portando lo stesso Gilbert a scegliere di sospendere le comunicazioni periodiche sul suo blog.
“This is not a throwback game”
L’intero discorso dei fan su Return to Monkey Island sembra però aver mancato il punto. Gilbert lo chiarisce a chiare lettere, sia prima dell’uscita che, con maggior forza, col gioco stesso.
Prima dell’uscita, innanzitutto, Ron Gilbert ha rilasciato delle dichiarazioni di perfetta chiarezza, che già suonano come pietre tombali sulle lamentele dei fan:
“I have made one pixel art game in my entire career and that was Thimbleweed Park,” writes Gilbert. “Monkey Island 1 and 2 weren’t pixel art games. They were games using state-of-the-art tech and art. […] If I had stayed and done Monkey Island 3 it wouldn’t have looked like Monkey Island 2. We would have kept pushing forward.”
Ron Gilbert, estratto dal suo blog, 1 maggio 2022

Cos’è, davvero, Monkey Island?
Questa è la prima bordata. L’idea che la “pixel art” debba essere la cornice obbligata entro il quale inserire un nuovo Monkey Island è una fallacia, una prigione mentale che infila a forza una saga rivoluzionaria all’interno di limiti troppo piccoli e meschini per lei stessa. Monkey Island è sempre stato un gioco in evoluzione, e in questo senso nemmeno la cel animation del terzo capitolo fu un tradimento della formula. Continua Gilbert, nello stesso intervento:
When Dave and I first started brainstorming Return to Monkey Island we talked about pixel art, but it didn’t feel right. We didn’t want to make a retro game. You can’t read an article about Thimbleweed Park without it being called a “throwback game”. I didn’t want Return to Monkey Island to be just a throwback game, I wanted to keep moving Monkey Island forward because it’s interesting, fun, and exciting. It’s what the Monkey Island games have always done.
Ibidem
Gilbert accusa fondamentalmente i fan di non aver capito che cosa fosse Monkey Island, e di volerlo ingabbiare in una nostalgia menzognera, di piccolo cabotaggio. Insomma, già questo stralcio sembrerebbe sufficiente ad affondare le critiche pretestuose. Monkey Island non è un “throwback game”, non è un gioco nostalgico, è un po’ di più e un po’ meglio. È un gioco sulla nostalgia stessa, sul crescere e sull’invecchiare, sul provare a ricatturare il passato e scoprirlo diverso, senza che questo sia nei fatti un male. È fondamentalmente un gioco paterno, un gioco sulla paternità.
Il cuore dell’esperienza, oltre l’avventura grafica
Se il discorso dei fan sembra castrare il percorso complessivo di Monkey Island, facendogli un grave torto, anche la stampa specializzata sembra peccare di visione di insieme9, sebbene in diversa misura e tipologia. Nella sua review, per esempio, PC Gamer descrive il gioco come uno “straightforward point-and-click adventure game that plays just as genre devotees expect”. Non in termini denigratori, attenzione, ma proprio come descrizione: si tratta di un puro e semplice punta e clicca, e questo dovete attendervi.
Intendiamoci, questa descrizione non è intrinsecamente falsa e il redattore non ha certo mentito. Return to Monkey Island è inserito in una cornice di questa fattura, ma è necessario spingersi un po’ più in là e capire che questa struttura così nota e condivisa a tutti è anche funzionale a raccontare l’esperienza di crescita di Gilbert, dei videogiochi tutti e della magia connaturata al raccontare una storia.

Elaine ci chiederà conto della distruzione di questo splendido ecosistema al solo scopo di costruire un mocio.
Nei fatti, Return to Monkey Island procede come è lecito attendersi da un “punta e clicca” uscito nel 2022: enigmi ben orchestrati, una interfaccia snella e convincente, ritmo perfetto, il tutto arricchito da generose dosi del consueto umorismo di casa. Tutto come previsto, insomma, ma il quadro dipinto risulta impreciso se non contestualizzato all’interno del meraviglioso racconto di sé, dei fan, e della storia di Monkey Island che Gilbert riversa fra le righe dell’avventura di Guybrush.
Nascosta in bella vista nel tessuto ludico vi è infatti una continua operazione di sollecito sibillino della nostalgia dei fan. Gilbert maneggia questa nostalgia con perizia, e vuole sia farla emergere romanticamente, con i continui richiami al passato della serie, ai suoi personaggi iconici e alle sue idiosincrasie, sia frustrarla nelle sue derive più oscure e totalizzanti.
Questo equilibrismo è manifesto fin dai primi istanti di gioco. Gilbert mantiene la sua antica promessa di ripartire alla fine del secondo capitolo10, dal famoso cliffhanger che vede Guybrush e LeChuck uscire bambini da una giostra del misterioso parco di Big Whoop insieme ai propri genitori. Il gioco inizia qui, eppure non qui: quel bambino che controlliamo in apertura è in realtà Boybrush, il figlio di Guybrush ed Elaine, che visita insieme ad un amico un normale parco giochi.
Il mistero del finale di Monkey Island, il velo di Maya che i giocatori volevano squarciare, resiste ancora saldo, saldissimo, contemporaneamente stuzzicando e sovvertendo le aspettative dei fan. Così facendo inoltre Gilbert ridichiara con forza la legittimità del terzo capitolo in termini di canone, addirittura rafforzando e benedicendo la sua scelta di non svelare l’arcano, ma anzi di buttare giù i fan dalle loro certezze.
Dato il là, il continuo del gioco è assolutamente coerente. Una buona cartina tornasole delle intenzioni di Gilbert è rappresentata dai duelli con le spade a base di insulti. Uno degli elementi più celebri della serie, già presente nel primo e terzo capitolo, è assente in Return to Monkey Island. È però un’assenza molto rumorosa, quasi gridata: per almeno tre volte viene suggerita una loro presenza, con sequenze sibilline che sembrano promettere nuovi duelli, nuovi insulti, salvo risolversi in dialoghi brevi e senza ulteriori sbocchi, giocando senza pace sulle aspettative del fan storico.
L’avventura è cosparsa di questi giochi e svolazzi, ma c’è un esempio che probabilmente dà ancora maggior visibilità del pensiero dei suoi autori. Sulla vecchia Mêlée Island, ricostruita pressoché identica a quella del primo capitolo, laddove una volta abitava la maestra di spada Carla è oggi presente un museo dedicato a memorabilia pirateschi. Il museo, curato da un entusiasta ed illuso fanaticodei pirati di nome Conrad, in mezzo a qualche pezzo storico, è però pieno di incredibili falsi, di inutile chincaglieria spacciata per mirabolanti artefatti. Al contempo anche alcuni reperti reali ripresi dai precedenti Monkey Island vengono distorti, ingigantiti, e le parole chiarificatrici del vecchio Guybrush vengono derise e scartate come fantasia.

Il “museum of pirate lore”, pieno di falsi e nostalgia.
È impossibile non rivedere in questo particolare rapporto fra Conrad e Guybrush lo stesso rapporto che esiste fra la fanbase e il team di Gilbert. L’ambiguità prende una piega sempre più assurda e parossistica, che tocca l’apice con un meraviglioso dialogo fra i due:
Guybrush: “This is absurd! It’s like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I’m not even mentioned in your stories!”
Conrad: “That’s what so great about this museum! Everyone makes their own connections with the exhibits, and it’s highly personal and different for everyone!”
Guybrush: “That’s not what I’m trying to sa yat all.”
Conrad: “That’s ok, you don’t need to say anything, just listen to what the exhibits tell you”.
Insomma caro Gilbert, grazie delle dritte ma il gioco lo dirigiamo noi.
Cercavo un approfondimento e tutto quello che ho trovato è questo stupido articolo
[Testo SPOILER]
Gilbert, per nostra fortuna, non ha mollato. Ha borbottato, chiudendo il blog e lamentandosi delle pretese dei fan, ma non ha mollato. I suoi rimbrotti non sono però quelli di un professore frustrato, bensì quelli di un padre. Laddove la prima metà del gioco era un buffetto ai fan, volta soprattutto a mostrare le incoerenze delle pretese dettate dalla nostalgia, la seconda metà è una meravigliosa esperienza di paternità pura e semplice.
Gilbert conosce la magia del videogame, e la maneggia sapientemente. Disseminate in questa fase vi saranno diverse sezioni che faranno rileggere al giocatore alcune delle proprie azioni durante l’avventura, spogliate però della comicità che le accompagnava e lasciate nude nella loro crudezza. Certo caro Guybrush, abbandonare un vecchio in una caverna sembrava proprio divertente mentre lo facevi, ma ti rendi davvero conto di quello che hai fatto? E soffiare la corona ad una regina appassionata del suo popolo, distruggendo un artefatto tradizionale nel mentre, era un giusto prezzo da pagare per arrivare al famoso segreto di Monkey Island?
Sarà Elaine, la dolce11 moglie di Guybrush, ad elencare le sue malefatte poco prima di raggiungere il segreto. Un bagno di realtà all’amato marito, che forse per la sua ossessione ha sacrificato un po’ troppo:
It’s just that I’m worried that The Secret can’t possibly measure up to the effort and anticipation. What exactly are you expecting to find? […] Be careful what you wish for.
Elaine Marley, introduzione alla quinta parte di Return to Monkey Island
Gilbert qui è durissimo. Dai buffetti si passa ad una vera lezione, che però a prima vista potrebbe essere fraintesa. Non sono davvero le azioni di Guybrush ad essere tremende. Monkey Island vive in una ucronia deviata, dove Guybrush è il buono, all’interno del racconto, e combatte il male, nonostante non sia certo uno stinco di santo. I crimini di Guybrush sono tali solo se estrapolati dal loro mondo, se guardati al netto della meravigliosa storia che gli è stata costruita intorno. Se togli la narrazione e la scrittura da un Monkey Island, se abbatti il contesto e le chiavi di lettura condivise, restano solo macerie. Perché quindi ribellarsi a chi questo mondo l’ha disegnato? Togliete chi ha lanciato la magia nei caraibi LucasArts, e rimarrà solo polvere.
Gilbert, da padre, non vuole questo. Borbotta e si lamenta perché vede dei figli travolgere tutto per avere il segreto di Monkey Island, e per averlo come vogliono loro. È in fondo questo il motivo per cui ha scelto di tornare su Monkey Island, e in coerenza con questa indole chiuderà la sua avventura.
Sul finale, infatti, Gilbert riprende la stessa impossibile conclusione di Monkey Island 2. Il segreto di Monkey Island non è altro che, di nuovo, solo un parco giochi, e i personaggi che Guybrush ha incontrato sono di fatto marionette. Il luna park questa volta è però firmato: “established 1989 by R.Gilbert”, recita una eloquente targhetta. La paternità è totale: con una limpida franchezza, il grandissimo autore ci sta semplicemente dicendo che Monkey Island è il suo parco giochi, e noi possiamo godercelo tutto, per quello che è e non per quello che vorremmo noi, a patto di salire sulla giostra.

Il misterioso finale del secondo capitolo è l’alfa e l’omega di Return to Monkey Island.
Non un parco giochi privato, chiuso, ma qualcosa di regalato a chi lo desidera. Le pretese, il desiderio di stringere a sé un segreto che non può esistere, sono la morte di Monkey Island, che invece prospera in questa magia, in questo affidarsi alle sapienti mani dei suoi creatori e al loro amore per raccontare qualcosa di così bello e aperto a tutti. Proprio a tutti, compresi i pasdaran della nostalgia, mai traditi in questo viaggio nella memoria e nel passato, nonostante le sberle non negate. A noi giocatori non resta che abbracciare questa rivelazione e, con Guybrush, spegnere letteralmente le luci prima di andarcene, felici.
FF
NOTE:
1 PC Gamer lo inserisce per esempio nella lista dei 50 videogiochi più influenti di sempre.
2 Come chiarito anche nella History of Zork, nell’archivio del New York Times
3 Per approfondire, si consiglia il paper “Let’s Begin Again: Sierra On-Line and the Origins of the Graphical Adventure Game”. American Journal of Play, Nooney, Laine (2017).
4 Labyrinth (1986), Maniac Mansion (1987), Zack McKracken and the Alien Mindbenders (1989).
5 Lo stesso Gilbert lo elogiò apertamente, come riportato in “Rogue Leaders: The Story of LucasArts”, Rob Smith, 2008.
6 O forse andare in una dimensione parallela, o forse scoprire che si trattava tutto di un gioco di bambini, o forse era solo un’illusione. Era, per l’appunto, un clamoroso cliffhanger.
7 Nel suo post sul proprio blog If I Made Another Monkey Island, pubblicato sul suo blog il 13 aprile 2013, Gilbert descrive lo stile grafico che avrebbe utilizzato come “Nice crisp retro art”.
8 Come riscontrabile nello stesso post sul blog di Gilbert: https://grumpygamer.com/april_fools_2022
9 Peraltro, le valutazioni date al gioco sono di assoluto rispetto, se è vero che al momento di stendere l’articolo il gioco ha un punteggio Metacritic di 86.
10 Sempre dal suo post “If I Made Another Monkey Island”, pubblicato sul suo blog il 13 aprile 2013.
11 In questo capitolo almeno; in altri episodi si mostra ben più arcigna.
COMMENTA SU TELEGRAM
SUPPORTACI SU KO-FI
NORCO: un “petroleum blues” tra psicogeografia e letteratura
NORCO: un “petroleum blues” tra psicogeografia e letteratura

Con sempre maggiore frequenza giornalisti, creator e critici tendono a comparare con troppa facilità e immediatezza i videogiochi che analizzano. Se questo atteggiamento da un lato è comprensibile, data la mole di contenuti che esce periodicamente, si rischia però di fare un torto a quei titoli che solo in apparenza e a uno sguardo superficiale paiono riprendere esperienze simili.
NORCO ne è il classico esempio. Subito paragonato a Disco Elysium e a Kentuky Route Zero, è stato solo scalfito da quell’approfondimento critico che, da opera unica nel suo genere, meriterebbe. Come Elden Ring ha rivisitato il romanticismo e portato il Sublime nel medium, NORCO incorpora con estrema naturalezza generi letterari ben codificati riuscendo a rielaborarli come nuova fonte di ispirazione. Non solo raccontando una storia di grande attualità politica attraverso un percorso di crescita sia umana che di consapevolezza, ma anche seguendo una tendenza di graduale distacco dal cinema come linguaggio, che per troppo tempo ha condizionato in modo esclusivo il videogioco.
“Creative Energy: The Rhythm of Louisiana” – Shell Oil Company

There was no such thing as silence. The noise never went away. The refinery exhaled an endless sigh.
Per capire NORCO bisogna prima di tutto conoscere Norco, Louisiana. Si tratta di una comunità suburbana sorta ai confini della New Orleans Refining Company e da cui prende il nome. I suoi abitanti sono operai della Shell, proprietaria della raffineria che si estende per chilometri, lavoratori dell’indotto ma soprattutto “Fenceline peoples” cioè persone che vivono nei pressi di pericolosi complessi industriali per indigenza e che vengono in qualche modo sfruttati per mantenere bassi i costi dei terreni, permettendo così alle aziende stesse di avere delle opzioni di acquisto soddisfacenti qualora avessero bisogno di espandersi1.
Aree di questo tipo sono come Stati all’interno di Stati dove i servizi, compresi quelli di sicurezza, sono spesso forniti esclusivamente dalle multinazionali di riferimento.
In questo contesto nasce Yuts, lead e game designer del gioco. Originario proprio di Norco, dopo un periodo di attivismo legato a un movimento di giustizia abitativa post uragano Katrina si laurea in “Urban and regional planning”, con una tesi sul sistema di “città petrolifere” parallele sorte in Louisiana. Comincia a lavorare per il G.I.S di New Orleans, un dipartimento dedicato alla ricerca storico-geografica atto a tracciare i cambiamenti territoriali in seguito all’antropizzazione e contestualmente forma un collettivo artistico, Geography Of Robots, per utilizzare questi dati in varie installazioni.
Presto Yuts si rende conto che il materiale prodotto non lo soddisfa, lo considera didascalico, ma sente l’esigenza di condividere l’incredibile ecosistema in cui vive2 e decide di usare il videogioco per porre questa domanda: cosa significa amare un territorio che sta pianificando la propria distruzione?
Refinery Eyes

You thought the ghosts of the lowlands wouldn’t find you hiding along the road.
In un 2017 distopico, Kay torna a Norco dopo aver scoperto la morte della madre Catherine, deceduta per colpa di un tumore legato con altissima probabilità al forte inquinamento della zona3. Ha girato gli Stati Uniti per trovare se stessa, periodo descritto in poche ma talmente incisive righe da valere tomi di world building (che non a caso ricordano le prime battute di “1997: Escape From New York”, battute che hanno ispirato William Gibson, uno degli autori preferiti di Yuts, nella sua visione autoriale).
Suo fratello Blake, unico familiare rimastole essendo orfana anche del padre Blue perché scomparso in un’esplosione avvenuta alla Raffineria nel 19884, è introvabile. Comincia così, con una classica e pretestuosa ricerca, un carosello di personaggi e situazioni talmente irrazionali dall’essere reali, o almeno reali come lo sono nei ricordi degli sviluppatori. È lodevole come ogni tematica trovi riscontro in ognuno di essi, riuscendo a contestualizzare una storia sì fantastica ma dolorosamente “normale”.
Il 2017 di NORCO ha poche differenze con il nostro, con degli elementi Cyberpunk che rendono finalmente giustizia non solo al genere ma al movimento, cioè una convivenza forzata tra uomo e tecnologia vecchia e nuova da parte di chi non se la può permettere ma che non può farne a meno, e non dalla quantità di led messi a schermo.
L’esempio più calzante è Million5, ex androide di sicurezza della Shield Company (l’equivalente Shell di questo mondo), ospitata e tenuta al sicuro da Catherine qualche anno prima e intenta a riparare un pickup degli anni novanta. O i richiami alla gig economy, alla bolla delle crypto e al riversamento di coscienze umane come costrutti per intelligenze artificiali, funestate però da una serie di pop-up pubblicitari e da funzionalità limitate a seconda del piano di abbonamento pre morte sottoscritto.
Forte anche l’accostamento a Jaques Derrida, per il quale
l’insegna suprema del potere è il potere di vedere senza essere visti.
Jaques Derrida, “Spectres de Marx”, 1993; trad. it. di G. Chiurazzi, “Spettri di Marx”, Cortina, Milano 1994
e nello Stato tecno-capitalista Shield si vive alla mercé di forze invisibili al di fuori del proprio controllo, non solo umane.
Southern Gothic

You wonder if such memories hide behind her constellation of eyes.
Oltre a queste contaminazioni e per rimarcare la propria appartenenza a uno specifico territorio, Geography Of Robots decide di utilizzare gli stilemi della letteratura “Southern Gothic” per raccontare la mitologia nascosta tra le nebbie dei bayou. Questo genere letterario ha origini importanti, riconducibili a William Faulkner e ai suoi scritti ambientati nella fantastica Contea di Yoknapatawpha ed è molto affine al realismo magico sudamericano.
Si tratta di lavori che hanno una forte caratterizzazione legata agli ambienti che poi si risolvono con interventi spesso mitici o fantastici, nel caso specifico con l’Hodoo ovvero una religione sincretica che unisce Cristianesimo, Islamismo e Animismo africano con lo spiritualismo autoctono.
Catabasi
Se la ricerca di Kay è un pretesto per rivivere la propria infanzia e cristallizzare nel tempo personaggi e situazioni care a Yuts, così come si era prefissato con l’inizio del progetto GoR, la sua risoluzione lo porta inevitabilmente a scavare nel presente della comunità e a porsi domande su capitalismo e ambientalismo.
Ispiratosi già ai tempi della tesi all’ecologista marxista Mike Davis, il giudizio espresso è molto vicino a quello del suo mentore e ripetuto in varie forme durante tutta l’esperienza di gioco. Nel 1992 in “City of Quartz”, due anni prima le rivolte di Los Angeles per Rodney King e anticipando di decenni le banlieue parigine, Davis descrive come le città e più in generale i siti economicamente rilevanti non siano altro che prigioni post-liberali, con piani di urbanizzazione controllati da pochi per i pochi (come già visto nei richiami a Derrida).
In una delle sue ultime interviste si esprimeva così:
I’m a wild, extreme leftist, but to me it’s clear that global capitalism can no longer guarantee the survival of the human race, in three ways, […] It can’t generate jobs. It cannot guarantee the public health of the world. And it cannot decarbonize the economy or transfer the resources to adapt the countries that bear the brunt of greenhouse gases. […] This seems an age of catastrophe, but it’s also an age equipped, in an abstract sense, with all the tools it needs. Utopia is available to us. If, like me, you lived through the civil-rights movement, the antiwar movement, you can never discard hope. I’ve seen social miracles in my life, ones that have stunned me—the courageousness of ordinary people in a struggle. Eleven years ago, Bill Moyers brought me on his show and presented me as the last socialist in America. Now there are millions of young people who prefer socialism to capitalism.
Dana Goodyear, “Mike Davis in the Age of Catastrophe“, The New Yorker, 24 Aprile 2020
Per questo motivo una storia famigliare si trasforma in una storia di ribellione a un “sistema-ambiente” da troppo tempo controllato da colletti bianchi che sono loro stessi vittime di un meccanismo collassato, con individui che praticano atti sovversivi e sabotaggi considerati quasi etici come unica risposta a un’alienazione che ha portato al disfacimento di ogni rapporto umano per colpa del capitale e della “white supremacy”.

This algorithm is the poetry of capital: we require semiotic weapons.
Con una maturità inusuale, Yuts non si limita però solo a questo, ma analizza anche la posizione anarco-nichilista che hanno molti degli abitanti di Norco. Paragonandoli ai sopravvissuti all’olocausto pone ai suoi personaggi la proverbiale domanda: ”Perché vi siete fatti condurre al massacro senza ribellarvi?”. E per caratterizzazione non sarebbe strano sentire Le Blanc, un investigatore privato con la passione per la clownerie che aiuta la protagonista e che per la natura della sua professione conosce benissimo tutto l’ethos del territorio, rispondere come Sopinsky nel suo “Blessed is The Flame”:
Sebbene abbiamo ereditato molte idee su come affrontare il dominio, sappiamo che nulla è scolpito nella pietra. Dagli strumenti e dalle ossa frantumate dei nostri predecessori, creiamo le nostre armi. Niente è garantito per funzionare, eppure attacchiamo a prescindere. Lo facciamo nudi, dopo aver gettato gli stracci della morale, dell’ideologia e della politica che si erano accumulati nel tempo. Affrontiamo questo mondo crudo, in tutta la sua orribile gloria. Neghiamo ogni verità e regola e procediamo con spirito di sperimentazione incendiaria. Sogniamo in grande, ci aspettiamo poco e celebriamo ogni momento di rottura. Cogliamo ogni opportunità per garantire che chi è al potere perda il sonno e che i suoi funzionari abbiano lavori miserabili. Dedichiamo le nostre vite a strappare i gerani che fiancheggiano i sentieri del campo di sterminio, a pisciare negli ingranaggi dei macchinari della società, e quando tutto il resto fallirà, seguiremo le orme di coloro che hanno trascorso i loro ultimi minuti nelle camere a gas cantando e scopando.
Che il godimento sia la fiamma benedetta che ci guida nel vuoto.
Sopinski, “Blessed Is the Flame: An Introduction to Concentration Camp Resistance and Anarcho Nihilism”, Public Domain Mark 1.0, citazione tradotta dal redattore
Anabasi
[DISCLAIMER: da qui in poi ci saranno alcuni SPOILER sul finale]
Dopo essere quindi sceso nuovamente all’inferno, Yuts è pronto a risalire grazie all’Hoodoo, al mistico e nello specifico grazie a un Ophanim, una ruota celeste o angelica che in alcuni libri dei Profeti trasportano il carro di Dio.
Sarà proprio l’apparente connessione con questa entità, forse dovuta all’essere dirette discendenti di Gesù Cristo, a spingere Catherine prima e Kay dopo a una scelta, ovvero se abbandonare questo piano terreno ascendendo tramite un razzo [sic] o continuare una (r)esistenza a oltranza. Le due donne però sono molto diverse, come a sottolineare un inevitabile distacco generazionale. Se Cat è mossa dal bisogno di lasciare un’eredità, Kay deve ancora capire chi è e abbandona NORCO, o ciò che ne resta, nella bruma mistica e sognante della palude.

You start toward the refinery that burns on the horizon.
Anche in questo caso ci sono molte citazioni legate all’infanzia dell’autore e a una scrittrice in particolare, Octavia E. Butler, che nel suo “Ciclo delle Parabole”6 racconta la storia di una ragazza che in seguito a un’apocalisse ambientale guida un gruppo di sopravvissuti dal sud degli Stati Uniti verso un futuro extraterrestre, mossa da una iper-empatia quasi messianica in pieno stile Southern Gothic.
NORCO è quindi tre storie in una: quella di un autore che volendo illustrare uno specifico momento del suo passato si rende conto che è impossibile, finendo invece per fotografare lo stato attuale delle cose. Quella di una comunità che è quasi inevitabilmente destinata a scomparire per colpa di poteri troppo radicati, poteri a loro volta giunti a una prossima decadenza. Ed è la storia di una famiglia perduta e ritrovata, che fa da collante politico in quanto sottolinea il riscatto attraverso la discendenza e le radici, così come fa la natura stessa del bayou tramite l’esistenza di forme di vita che si innestano su ciò che muta continuamente.
Luca 8, 17
Non c’è nulla di nascosto che non debba essere manifestato, nulla di segreto che non debba essere conosciuto e venire in piena luce
Dal Vangelo di Luca, capitolo 8 versetto 17, C.E.I/Gerusalemme
La spiritualità contro un totalitario sistema economico disumanizzante, l’importanza di essere comunità. Questo è ciò che tiene insieme un gioco che, purtroppo, paga lo scotto di essere nato inizialmente come altro ed è, per quanto graziato da una bellissima pixel art, abbozzato e imperfetto in diverse sue parti. Però pochi prodotti di intrattenimento al giorno d’oggi offrono una così chiara visione politica: basti pensare al pur incensato Citizen Sleeper, che vorrebbe affrontare tematiche simili ma riesce appena a scalfirle, e tanto basta per renderlo degno di essere giocato e approfondito.
Sperando, in qualche forma, di ritrovare noi stessi.
EF
Si ringrazia Francesco Farina per la consulenza sull’Ophanim e per il contributo generale.
NOTE:
1 Rachel Massey, “Environmental Justice: Income, Race, and Health”, Tufts University Global Development and Environment Institute, 2014.
2 Marisa Clogher, “No Place Like Home a Q&A with Norco’s Yuts”, Antigravity, ottobre 2021.
3 “Enviromental Racism in Death Alley, Louisiana”, Forensic Architecture, 28 giugno 2021.
4 Qui il gioco fa un riferimento all’incidente avvenuto all’impianto nel 1988 “canonico”, incidente in cui persero la vita sette persone e al quale assistette lo stesso Yuts. “Inspection: 100478866 – Shell Oil Company”, United States Department Of Labor.
5 Come Molly Million, coprotagonista del racconto Johnny Mnemonic di William Gibson.
6 “Parable of the Sower”, Four Walls Eight Windows, 1993; “La parabola del seminatore”, trad. it. Anna Polo, Solaria 4, Fanucci Editore, 2000.
“Parable of the Talents”, Seven Stories Press, 1998;” La parabola dei talenti”, trad. it. Anna Polo, Solaria Collezione 4, Fanucci Editore, 2001.
COMMENTA SU TELEGRAM
SUPPORTACI SU KO-FI